09 maggio 2015
06 maggio 2015
Profughi di oggi come gli italiani di ieri?
In alcuni commenti sui continui sbarchi lungo le coste
italiane, i «profughi» (preferisco chiamarli così e non «migranti») africani e
asiatici sono stati paragonati ai «migranti» italiani del secolo scorso, in
quanto anch’essi erano persone in fuga, se non dalla guerra da una condizione
per loro insostenibile, erano alla ricerca di un avvenire migliore e spesso
dovevano affrontare viaggi rischiosi. Il paragone, da certuni molto criticato,
non è fuori luogo, pur essendoci sostanziali differenze da tener presenti in
questo tipo di confronti.
Premesse essenziali
Anzitutto, quando si paragonano i profughi di oggi con i
migranti italiani di ieri, ci si deve rendere conto che si sta cercando di
mettere a confronto due realtà distanti fra loro oltre un secolo. Inoltre,
sebbene esistano alcune analogie tra questi due fenomeni, non trovo appropriato
che si confrontino «profughi» con «migranti».
 |
| Il naufragio della speranza, di Caspar David Friedrich |
Quelli di oggi non sono propriamente «migranti» nel
significato comune del termine che fa pensare generalmente a persone che,
facendo uso della loro libertà di espatrio, si trasferiscono in un altro Paese
alla ricerca di un lavoro e sperano di poter fare ritorno in patria in
condizioni migliori. Quelli che sbarcano oggi sulle coste meridionali italiane
(ma anche maltesi, greche, spagnole, ecc.), talvolta clandestinamente, sono
nella stragrande maggioranza, «profughi» che fuggono da una realtà disperata
perché funestata da guerre e carestie o in cui rischiano la vita per una
persecuzione in atto e sono quindi in condizione di chiedere l’asilo ed essere
accolti come «rifugiati».
I migranti italiani di oltre un secolo fa non erano profughi
o rifugiati, perché non fuggivano né da un Paese in guerra né da un Paese dove rischiavano
la vita a seguito di persecuzioni. In genere non erano nemmeno costretti a
partire dalla miseria perché allora, come osservava nel 1901 il senatore Achille
Visocchi, in Italia il lavoro non mancava, in particolare quello agricolo, ma
erano spinti «dalla speranza e dalla voglia di guadagnare molto…».
Molti cercarono fortuna
altrove anche perché il disagio sociale e la disperazione dovuti al malgoverno
piemontese era divenuto insopportabile. In generale, tuttavia, i
migranti italiani dell’Ottocento e inizio Novecento partivano verso le Americhe
o verso alcuni Paesi europei, per motivi di lavoro, talvolta addirittura a
richiesta, come nel caso dell’immigrazione italiana in Svizzera per la
costruzione delle grandi trasversali transalpine. Inoltre, emigravano quasi
tutti avvalendosi del diritto di espatrio che veniva loro riconosciuto dalle
leggi dell’epoca, raramente in clandestinità.
Le differenze tra profughi di oggi e migranti italiani di
ieri sono quindi notevoli e si commetterebbe un errore storico grossolano non
tenerne conto. Eppure alcune analogie, come si vedrà, non possono sfuggire.
Analogie tra profughi di oggi e migranti italiani in
partenza per le Americhe
Anzitutto, profughi e migranti hanno in comune la speranza
di migliorare le condizioni di vita proprie e delle loro famiglie. Per entrambi
è stata ed è questa la molla che li ha spinti e li spinge a partire, a
sopportare viaggi disumani, a rischiare di non trovare la felicità inseguita. La
speranza di trovar lavoro e far fortuna in fretta era talmente forte che i migranti
italiani diretti nelle Americhe non venivano fermati nemmeno dalla prospettiva
di un viaggio lungo e penoso e dall’incognita rappresentata dal Paese di
destinazione, di cui molto spesso non sapevano nulla.
Per molti partenti, sosteneva nel 1888 il senatore Paolo
Mantegazza, «l'America è ancora un mito, è un paese in cui si va per
fare fortuna in breve tempo. I nostri emigranti non distinguono il Nord dal
Sud, né New York da S. Paulo». Qualcosa di simile si potrebbe dire
facilmente anche riguardo ai profughi di oggi. Ma le analogie non finiscono
qui.
Anche il numero delle partenze è analogo. Oggi si parla di
milioni di persone che dal Nord Africa, dall’Africa subsahariana e dall’Asia sono
pronti a partire verso i Paesi europei, almeno inizialmente, per proseguire in
seguito verso altri continenti. Ma quanti ricordano i milioni di italiani
espatriati negli ultimi decenni dell’Ottocento e gli inizi del Novecento fino
alla prima guerra mondiale? Ebbene si tratta di oltre 14 milioni. Anche allora
una parte dei migranti si fermava in Europa, ma la maggior parte partiva per
mete oltreoceano, soprattutto Argentina, Brasile e Stati Uniti.
Trafficanti di ieri e di oggi
Oggi da parte del governo italiano e della Commissione
dell’Unione europea si dichiara la lotta agli scafisti, ai «trafficanti di
disperati», ai «moderni schiavisti» (e si spera che abbia successo), ma forse molti
non sanno che anche sulla prima ondata migratoria degli italiani verso le
Americhe c’era chi lucrava sulla povera gente. Erano i cosiddetti «agenti di
emigrazione», che reclutavano operai e contadini per conto di imprese e
compagnie di navigazione, facendo balenare loro una volta giunti a destinazione
facili fortune e ricchezze straordinarie. Ignoranti com’erano, molti si
lasciavano illudere, racimolavano il denaro necessario e acquistavano i
biglietti di viaggio.
Contro questi avidi faccendieri senza scrupoli che sfruttavano
l’ingenuità e l’ignoranza di tanti contadini soprattutto meridionali si scagliò
nel 1887 il vescovo di Piacenza oggi beato Giovanni Battista Scalabrini, definendoli
«speculatori che fanno vere razzie di
schiavi bianchi per spingerli, ciechi strumenti di ingorde brame, lontano dalla
terra natale col miraggio di facili e lauti guadagni». Secondo Scalabrini
essi non solo lucravano sul numero dei migranti che riuscivano a imbarcare, ma si
rendevano in qualche modo responsabili anche del loro triste destino, non
informandoli sufficientemente né sulla reale destinazione (condizioni
climatiche e quant’altro) né sull’attività che avrebbero svolto. Infatti «l’agente può, nella miglior buona fede,
mandare alla rovina tanta gente, non essendo egli obbligato ad avere cognizioni
su questo punto, come vi sono obbligati per esempio gli agenti Svizzeri».
Monsignor Scalabrini
non era l’unico a contestare questi intermediari «inutili e dannosi»,
perché sfruttavano non solo i poveri migranti ma anche chi li richiedeva. Anche il governo ne era a conoscenza e
dovette intervenire più volte presso i prefetti invitandoli ad essere
più vigilanti. Gli agenti vennero poi aboliti definitivamente nel 1901.
Condizioni di
viaggio disumane ieri come oggi
Anche le
condizioni di viaggio di allora e di oggi presentano somiglianze
impressionanti. Ricordava nel 1888 al Senato, nel corso della discussione della legge sull’emigrazione, il
senatore Augusto Pierantoni: « ... Nella stazione di Genova tante
volte vidi adunate in carovana emigrante le nostre classi operaie ed agricole
giacere sul nudo sasso, dormendo sotto i portici, sotto gli alberi nella piazza
ove sorge la statua di Cristoforo Colombo, aspettando l'agente di emigrazione e
l'ora dell'imbarco. Quel triste spettacolo mi premeva il cuore…».
E un altro senatore, Pietro
Manfrin Di Castione, riferiva qualche
dettaglio delle condizioni di viaggio dei migranti che s’imbarcavano a
Genova diretti alle Americhe:«La via crucis dell'esodo comincia dall'Italia
(...). Chi in questi giorni si trova a Genova ed ha veduto anche per semplice
curiosità l'imbarco di tante migliaia di individui, ed ha osservato il modo e
le condizioni con cui sono lasciati partire, non ha potuto fare a meno di
fremere di sdegno. I vapori partono carichi di carne umana, misurata a metri
cubi (...). Tutti vogliono guadagnare sul povero emigrante, anche il Municipio
di Genova….».
Purtroppo anche i
rischi dei viaggi di oggi su barconi sgangherati non sono molto diversi da
quelli che correvano i migranti italiani diretti in America. Anche allora per
questo trasporto di carne umana venivano usati piroscafi vecchi, spesso già in
disarmo, che potevano ospitare al massimo 700 persone, ma ne imbarcavano anche
più di 1000. Erano chiamati «vascelli della morte» perché non davano alcuna
garanzia di arrivare a destinazione. Di fatto i naufragi erano frequenti anche
allora con centinaia, talvolta migliaia di morti, molti dei quali migranti italiani:
576 nel 1891, 549 nel 1898, 550 nel 1906,
ecc.
Come si vede da questi
cenni, esistono molteplici analogie tra i fuggitivi di oggi e i migranti
italiani di ieri, anche se tra una realtà e l’altra è intercorso più di un
secolo. Ricordare il passato, per lo più rimosso dalla memoria collettiva
italiana, dovrebbe aiutare chiunque osserva il fenomeno degli sbarchi e dei
profughi spesso abbandonati a sé stessi a indignarsi per come talvolta vengono
trattate queste persone, per le soluzioni insoddisfacenti che sono state
adottate a livello italiano ed europeo nei loro confronti, per i tentativi ignobili
di scaricare su di essi la rabbia dei cittadini italiani più diseredati, come
se fossero loro la causa del disagio sociale, della povertà e della
disoccupazione che si sta espandendo oggi in Italia.
 |
| Gianni Morandi |
Per una politica immigratoria lungimorante e sostenibile
Ha fatto bene Gianni
Morandi a ricordare su Facebook le umiliazioni, le angherie, i soprusi e le violenze che hanno dovuto
sopportare centinaia di migliaia di italiani, nel secolo scorso, andando a cercar
fortuna e un futuro migliore per i propri figli in America, Germania, Canada...
Il ricordo del passato
dovrebbe anche aiutare, secondo me, non solo a non fare agli altri quel che è
stato fatto a tanti nostri connazionali, ma anche a considerare l’accoglienza
dei profughi di oggi come una sorta di azione riparatrice dell’Europa opulenta,
un tempo colonizzatrice di molti Paesi da cui fuggono oggi milioni di profughi,
perché se in quei Paesi ci sono guerre, povertà, corruzione, sottosviluppo, non
si può onestamente sostenere che l’Occidente sia totalmente esente da
responsabilità dirette o indirette.
Resto tuttavia
convinto che la miglior soluzione al problema di profughi, in generale, non sia «valutare l’uso della forza», come veniva proposto da più parti alla vigilia del vertice europeo di aprile sulla questione dei profughi, ma sia una
politica di aiuto ampia e coordinata dei Paesi più industrializzati per lo sviluppo serio e durevole dei Paesi da
dove si fugge, congiunta ad una moderna politica immigratoria lungimirante e
sostenibile.
Giovanni Longu
Berna, 6.5.2015
Berna, 6.5.2015
29 aprile 2015
Svizzera: naturalizzazione agevolata per la terza generazione
Questa dovrebbe essere, finalmente, la volta buona. L’11
marzo scorso il Consiglio nazionale (CN) ha infatti approvato a stragrande
maggioranza (122 sì, 58 no e 4 astensioni) un progetto di legge sulla naturalizzazione
agevolata della terza generazione di stranieri, elaborato dalla Commissione
delle istituzioni politiche (CIP-N) su una iniziativa parlamentare della
consigliera nazionale italo-svizzera Ada Marra, in cui si affermava
perentoriamente che «la Svizzera deve riconoscere i propri figli».
 |
| L’on. Ada Marra con Giovanni Longu |
L’approvazione del CN, una delle due camere dell’Assemblea
federale, non ha avuto un grande rilievo nei media e probabilmente non ha
entusiasmato nemmeno Ada Marra, che attende ormai dal 2008 una decisione definitiva
sulla sua iniziativa e dovrà ancora aspettare, non si sa quanto, il risultato
finale. Il progetto dev’essere infatti ancora esaminato e approvato dal Consiglio
degli Stati e spetterà poi al popolo svizzero dire l’ultima parola.
Chi conosce anche solo sommariamente l’iter legislativo
svizzero sa bene che si tratta di un procedimento piuttosto lungo e laborioso.
Nel caso specifico, poi, sette, otto o più anni rappresentano una durata
accettabile, se si pensa che il tema della naturalizzazione agevolata per i
figli e nipoti di immigrati (ossia giovani stranieri nati e cresciuti in
Svizzera) è iniziata oltre un secolo fa.
Argomentazioni secolari
Nella motivazione della sua iniziativa, Ada Marra sosteneva
che «la Svizzera deve riconoscere i propri figli
e smettere di chiamare "straniere" persone che non lo sono. Infatti,
le persone nate in Svizzera da genitori nati in Svizzera da genitori che hanno
soggiornato per oltre vent'anni in Svizzera non sono più straniere: la maggior
parte di loro conosce solo vagamente la lingua degli avi e non superebbe mai un
esame linguistico teso a determinare se sono integrate nel Paese di cui hanno
la cittadinanza. Le persone della terza generazione hanno (…) le radici in
Svizzera, indipendentemente dalla realtà in cui vivono e dal loro livello
socioeconomico. Sono il prodotto della realtà elvetica».
A ben vedere, le argomentazioni della Marra non sono né
rivoluzionarie né del tutto originali. Qualcosa di simile si trova infatti già nelle
motivazioni di una analoga iniziativa del 1912 con cui si chiedeva l’introduzione
nella Costituzione federale del principio dello «jus soli», ossia il diritto
alla cittadinanza svizzera per chi nasceva in Svizzera. Allora la questione era
stata sollevata da una commissione di esperti in relazione al pericolo
dell’«inforestierimento della Svizzera», ritenendo che un buon antidoto sarebbe
stato proprio la naturalizzazione automatica di chi nasceva in Svizzera.
Alla base dell’iniziativa c’era un pensiero assai semplice:
molti «stranieri» in Svizzera fin dalla nascita sono di fatto già «assimilati»
o potrebbero esserlo facilmente, basterebbe concedere loro la naturalizzazione
fin dalla nascita. Inoltre si riteneva, ragionevolmente, che riducendo con la
naturalizzazione automatica il numero degli stranieri anche il problema
dell’inforestierimento si sarebbe per così dire sgonfiato da solo. L’iniziativa,
benaccolta negli ambienti politici, non fu portata avanti a causa della prima
guerra mondiale, che impose altre priorità. Purtroppo anche dopo la guerra non
venne più ripresa fino agli anni ’90 del secolo scorso e all’elaborazione di un
progetto di legge respinto in votazione popolare nel 2004.
Osservo marginalmente che se le motivazioni a favore
dell’iniziativa Marra non sono di per sé nuove, non lo sono nemmeno le
argomentazioni contro la stessa iniziativa. Quando il consigliere nazionale
dell’Unione democratica di centro (che in realtà è di destra) Hans Fehr obietta
che non si deve compromettere la nazionalità elvetica (cha ha qualcosa di unico
al mondo e fornisce molte libertà e diritti) e che a suo avviso il progetto
mira soltanto a far calare massicciamente il tasso di stranieri in Svizzera,
non dice nulla di nuovo rispetto alle obiezioni che venivano mosse
all’iniziativa del 1912.
Verso una decisione storica
Occorre tuttavia sottolineare anche l’attualità e
ragionevolezza dell’iniziativa di Ada Marra e della successiva proposta della
CIP-N in quanto sono state recepite a mio avviso in misura più che sufficiente
due istanze provenienti dal mondo politico e dall'opinione pubblica. La prima
riguarda il meccanismo della naturalizzazione, che non dev'essere né automatico
né troppo facile o troppo difficile, ma equo, rispondente a precise condizioni valide
in tutta la Svizzera. La seconda istanza è quella di un’opinione pubblica ormai
stanca degli atteggiamenti marcatamente xenofobi e sempre più orientata a
considerare svizzeri a tutti gli effetti coloro che si sentono effettivamente
tali fino ad apparire quasi ridicolo considerarli ancora «stranieri». Lo ha ribadito
al CN a nome della CIP-N il socialista Andy Tschümperlin: «I nipotini degli
immigrati non sono più stranieri. Non parlano più, o male, la lingua dei loro
nonni e i legami con il paese di origine sono simbolici».
In base al progetto di legge approvato
dal CN l'ottenimento della nazionalità elvetica dovrà avvenire secondo una
procedura uniforme a livello nazionale e non in maniera automatica ma a
richiesta, in quanto l’interessato o i suoi genitori dovrebbe o dovrebbero farne
esplicita richiesta. In questa maniera è stato rimosso l’ostacolo principale che
impedì l’approvazione dell’analogo progetto di legge nella votazione popolare
del 2004.
Il progetto ora approvato sottolinea
anche in maniera inequivocabile che la naturalizzazione agevolata presuppone
nei candidati di essere bene integrati e che anche i loro genitori e persino i
loro nonni abbiano (avuto) legami stretti con la Svizzera.
Allo stato attuale dell’iter parlamentare e della percezione
del problema nell’opinione pubblica, tutto lascia ben sperare. Solo dopo
l’approvazione definitiva si potrà comunque parlare di una decisione «storica»
e l’aggettivo non dovrà sembrare esagerato se solo si pensa al tempo trascorso
dalle prime discussioni oltre un secolo fa.
Giovanni Longu
Berna, 29.04.2015
Berna, 29.04.2015
UE in confusione tra profughi e migranti
I problemi della «migrazione» stanno diventando acuti non solo
per l’Europa ma per il mondo intero. Sono milioni le persone in movimento,
spesso in condizioni disumane, «alla ricerca - per citare Papa Francesco – della
felicità» o comunque «di una vita migliore». Se finora questi spostamenti di
masse avvenivano nella quasi totale indifferenza delle popolazioni non
direttamente coinvolte, oggi, di fronte a episodi drammatici sempre più
frequenti come i numerosi naufragi nel Mediterraneo, l’opinione pubblica
mondiale è più consapevole dell’entità e della gravità del fenomeno. Le
istituzioni sono prese di mira perché ritenute responsabili non tanto delle
cause delle migrazioni, quanto piuttosto della cattiva o comunque insufficiente
gestione del fenomeno.
UE in confusione
Per non parlare dell’inerzia delle Nazioni Unite, mi
soffermo solo sulla pochezza degli interventi decisi la settimana scorsa dall’Unione
europea (UE). Di fronte all'ennesimo dramma che si è appena consumato nel Mediterraneo
tra la Libia e l’Italia, il governo italiano ha fatto bene a chiedere la
convocazione urgente del Consiglio UE, ma non ha fatto nulla per provocare una
seria discussione su una politica migratoria europea comune.
Considero questa mancanza grave perché l’Italia, più di
qualsiasi altro Paese europeo, dovrebbe sapere che se la migrazione non è ben
gestita può creare seri problemi politici e sociali non solo nei Paesi di
partenza ma anche in quelli di transito e soprattutto di arrivo. Il fatto è che
non avendo l’Italia alcuna linea guida in materia d’immigrazione non può
nemmeno chiederla all’UE. E’ emblematica al riguardo la confusione
terminologica tra migranti, clandestini, richiedenti l’asilo, profughi,
rifugiati e altro ancora. Essa denota che non ci si rende conto che l’approccio
nei confronti dei «migranti» non può essere lo stesso che si deve avere con i «profughi»
e i «richiedenti l’asilo», per non parlare dei clandestini o infiltrati
terroristi. Di fatto non esiste né in Italia né nell’UE una politica
immigratoria comune.
«Triton» rinforzato, ma problemi di fondo irrisolti
L’ennesima conferma giunge dalla riunione straordinaria del
Consiglio UE. Poco meno di due anni fa l’Italia e l’UE avevano varato la missione
«Mare Nostrum» per fronteggiare l’emergenza umanitaria nel Mediterraneo (fino
alle coste del Nord Africa) dove i naufragi di profughi erano frequenti. Nel novembre
2014 la missione Mare Nostrum è stata sostituita con l’operazione Triton,
meno costosa e limitata al controllo delle acque territoriali italiane fino a
30 miglia nautiche dalla costa. Nella riunione del 23 aprile scorso, invece di
affrontare l’esigenza di nuovo approccio globale al fenomeno, il Consiglio UE si
è impegnato soltanto a rinforzare Triton (triplicandone il finanziamento) senza
cambiarne sostanzialmente la missione, ossia pattugliare le coste italiane per
impedire l’ingresso illegale nelle acque territoriali dell’UE.
In questo modo non si risolvono certo i problemi che stanno
all'origine del fenomeno, anzi non si fa che aumentare la confusione e
alimentare la disputa politica tra chi vorrebbe usare le maniere forti
(respingimenti, affondamento dei barconi con l’impiego di droni, blocco navale
sulle coste africane o addirittura con l’invasione della Libia) e chi non vuole
sottrarsi agli obblighi del soccorso in mare (anche oltre le 30 miglia dalla
costa), dell’accoglienza e della solidarietà (pur dichiarando guerra ai
trafficanti e ai nuovi schiavisti). All'interno dell’UE non c’è nemmeno la
condivisione di un metodo per l’accoglienza e la ripartizione dei «rifugiati»
tra tutti i Paesi membri.
La problematica della «migrazione» in senso proprio è
rimasta totalmente assente perché il quadro generale di riferimento resta una UE
che intende difendere i suoi confini (e i suoi interessi) da chiunque cerchi di
penetrarvi illegalmente, ovviamente fatte salve le convenzioni internazionali sui
doveri di soccorso a naufraghi e richiedenti l’asilo. Resta aperto, a mio
avviso, il problema degli sbarchi di tutti gli altri: se non hanno diritto
all'asilo (e in proposito l’UE ha chiesto all'Italia che la registrazione dei
rifugiati avvenga in modo adeguato secondo le regole UE!) vanno accolti o
espulsi? Altrimenti detto, dopo l’eventuale soccorso in mare, l’identificazione
e l’accoglienza negli appositi centri, dovranno essere trattenuti in vista
dell’espulsione o «convertiti» in immigrati regolari (anche se non hanno un
lavoro e mezzi di sostentamento) con la libertà di muoversi dove vogliono?
Mancanza di una visione comune europea
Per dare risposte concrete a queste o a simili domande è
forse indispensabile attuare politiche diverse ma complementari: almeno una fondata
sulla solidarietà nei confronti dei «profughi» costretti a fuggire (a causa di
guerre, persecuzioni, pericoli gravi imminenti) e una fondata su considerazioni
di tipo essenzialmente economico nei confronti dei «migranti». Per essere
efficaci, andrebbero condivise da tutti i 28 Paesi dell’UE e armonizzate in una
visione strategica comune che coinvolga anche i Paesi da cui provengono i
profughi/migranti.
Purtroppo questa visione comune manca, per cui risultano
insufficienti non solo la solidarietà praticata, ma anche l’atteggiamento dimostrato
nei confronti dei profughi e soprattutto la presa a carico, almeno in parte, dei
problemi dei Paesi da cui si continua a fuggire. Eppure appare evidente che per
impedire che si fugga non occorre creare sbarramenti, ma attuare una politica
d’investimenti massicci sul posto. Almeno a medio e a lungo termine ne
beneficerebbe sicuramente anche l’Unione europea. O si preferisce continuare a
rincorrere l’emergenza profughi, l’emergenza migranti, l’emergenza…?
Giovanni Longu
Berna, 29.04.2015
Berna, 29.04.2015
22 aprile 2015
Sbarchi di profughi: né clandestini né migranti
Nota: Questo articolo è stato scritto prima che si
conoscesse l'ennesima tragedia dei profughi in fuga verso l'Italia. Penso che ponga
un problema non solo di carattere terminologico ma anche politico, che l’ultimo
tragico evento non fa che aggravare. E’ pertanto auspicabile che la politica
internazionale trovi presto la necessaria convergenza e determinazione per
adottare soluzioni coordinate ed efficaci al grave problema di questi esodi, informando
l’opinione pubblica con un linguaggio consono e coerente (22.05.2015)
Le notizie di salvataggi in mare e sbarchi sulle coste italiane, all’ordine del giorno già da alcune settimane, saranno sempre più frequenti durante la stagione estiva. Se lo scorso anno sono sbarcate 170.000 persone, per quest’anno se ne prevedono almeno il doppio. Aumenta purtroppo anche il numero delle vittime dei frequenti naufragi. Si parla già di emergenza profughi. I centri di accoglienza sono al collasso. L’«operazione Triton» (controllo delle frontiere dell’Unione europea nel mar Mediterraneo) è ritenuta del tutto inadeguata sia per i controlli che per i salvataggi in mare.
.jpg) I continui sbarchi di masse in fuga dalle guerre e dalla
miseria interpellano non solo la classe politica italiana, dell’Unione europea
e delle Nazioni Unite, ma anche le nostre coscienze. Cosa fare per gestire con
senso di umanità il fenomeno? Cosa bisognerebbe intraprendere per evitare che
tanta gente sia costretta ad abbandonare le loro terre? Come vanno considerate
le persone che arrivano da noi? Che cosa si può e si deve fare per venire
incontro ai loro bisogni? La solidarietà è solo una virtù cristiana o anche un
dovere civico?
I continui sbarchi di masse in fuga dalle guerre e dalla
miseria interpellano non solo la classe politica italiana, dell’Unione europea
e delle Nazioni Unite, ma anche le nostre coscienze. Cosa fare per gestire con
senso di umanità il fenomeno? Cosa bisognerebbe intraprendere per evitare che
tanta gente sia costretta ad abbandonare le loro terre? Come vanno considerate
le persone che arrivano da noi? Che cosa si può e si deve fare per venire
incontro ai loro bisogni? La solidarietà è solo una virtù cristiana o anche un
dovere civico?
Opinione pubblica disorientata
L’opinione pubblica è disorientata. Non riesce ad avere
risposte soddisfacenti a queste o a simili domande. A parte l’aggiornamento
pressoché quotidiano del numero degli arrivi, degli sbarchi e dei morti, con
qualche elogio sporadico alla professionalità dei soccorritori e alla
generosità dei volontari, i media non offrono spunti di discussione alla
ricerca di soluzioni sostenibili. Sembrano appiattiti sulla registrazione delle
reciproche accuse tra i partiti e delle critiche al governo Renzi per una
presunta arrendevolezza nei confronti dell’Unione europea, accusata persino dai
vescovi italiani di «lavarsene le mani». Nessuna informazione giunge
all’opinione pubblica su eventuali piani per gestire meglio il fenomeno o
addirittura per risolverlo alla radice.
Eppure l’opinione pubblica dovrebbe almeno sapere se in
questo campo sono in corso per lo meno discussioni ad alto livello (diplomazia
internazionale, Unione europea) per predisporre interventi radicali efficaci (politici,
militari, finanziari o di altro genere) o si pensa soltanto a rafforzare i
controlli alle frontiere per impedire (o ritardare?) l’assalto alla fortezza
Europa. Ogni tanto si sente parlare di interventi militari (ad esempio in
Libia) per impedire le partenze dei barconi, di organizzare nei Paesi
nordafricani centri di accoglienza e di esame delle richieste di asilo, di
predisporre massicci piani d’investimenti nei principali Paesi colpiti dalla
povertà, da cui si cerca di fuggire. Non si sente mai parlare di un comune
piano d’integrazione in Europa per poche centinaia di migliaia di persone che credono
nell'Europa come nei secoli passati gli europei hanno creduto nell'America. Forse
ci sono ancora europei che credono che la fortezza Europa sia imprendibile?
Non intendo certo incolpare i media se l’opinione pubblica è
disorientata. In effetti i media hanno il compito d’informare sui fatti e sulle
idee e se queste mancano non se le possono certo inventare immaginando di
leggere nei cervelli di Renzi, della Mogherini, di Juncker
o di altri responsabili politici italiani ed europei. Eppure anche i media sono
responsabili della maniera con cui vengono presentati i fatti e la loro
interpretazione.
Bando alle confusioni
Voglio dire che in questo campo, delicato e drammatico, le
parole contano più che mai e non mi sembra che quelle utilizzate più di
frequente siano sempre chiare, comprensibili e veritiere. Soprattutto nei
confronti delle persone che sbarcano dai gommoni o dalle navi che le hanno
soccorse in mare, indicarle in un modo o in un altro non è indifferente. Non si
può continuare a chiamarle a piacimento migranti, clandestini, richiedenti
l’asilo, profughi e quant'altro. Questi termini non sono equivalenti e le
persone a cui vengono attribuiti non sono raggruppabili in un’unica categoria.
Aggiungo che dall'uso delle parole dipende molto l’impatto
sociale che il fenomeno sta generando in Italia (per limitare l’attenzione al
Paese maggiormente coinvolto). Se, di fronte ai racconti pressoché quotidiani
degli sbarchi, ma anche purtroppo dei naufragi, e soprattutto delle difficoltà
oggettive di accogliere «dignitosamente» (come vorrebbero le regole
internazionali) tutti coloro che riescono ad approdare sul suolo italiano
l’opinione pubblica è frastornata, lo si deve anche al tipo di narrazione che
ne fanno i media e i leader politici tra due estremi: da una parte il facile buonismo
di alcuni, anche tra le alte cariche dello Stato, e dall'altra l’ingiustificata
paura di quanti si sentono minacciati dall'eccessiva presenza di stranieri,
soprattutto all'estrema destra politica.
Gli uni, che considerano gli sbarcati dei «migranti» da
soccorrere, accogliere e sistemare, peccano di ingenuità e forse anche di
falsità perché sembrano minimizzare il fenomeno e negare l’incapacità
dell’Italia (ancora in crisi) di risolverlo, soprattutto quando si tratta di
dare ai «migranti» un alloggio dignitoso e garantire una sistemazione
definitiva, ossia un lavoro, che al momento è insufficiente anche per gli
italiani.
Gli altri, che rappresentano gli sbarcati come «clandestini»
e «invasori», peccano di becera xenofobia e di smemoratezza perché sono solo
capaci di agitare spauracchi inverosimili (infiltrazione di terroristi
islamici, invasione in massa di clandestini, aumento della microcriminalità, ecc.)
e vedono nei «respingimenti» l’unica soluzione possibile. Al confronto di certi
politici italiani nemmeno Schwarzenbach, in Svizzera, era così radicale nei
confronti dell’immigrazione di massa (italiana, per chi l’avesse scordato).
.jpg) Il problema del linguaggio è molto serio e spesso
sottovalutato, ma è proprio sull'uso sconsiderato delle parole che sorgono in
Italia le prime incomprensioni e le contrapposizioni politiche. In certi
ambienti, penso in particolare alla Lega Nord, si privilegia il termine
«clandestini», che è invece rifiutato nettamente da tutta l’area di
centrosinistra. In questa si parla ormai quasi esclusivamente di «migranti», più
raramente di «richiedenti l’asilo» e di «profughi».
Il problema del linguaggio è molto serio e spesso
sottovalutato, ma è proprio sull'uso sconsiderato delle parole che sorgono in
Italia le prime incomprensioni e le contrapposizioni politiche. In certi
ambienti, penso in particolare alla Lega Nord, si privilegia il termine
«clandestini», che è invece rifiutato nettamente da tutta l’area di
centrosinistra. In questa si parla ormai quasi esclusivamente di «migranti», più
raramente di «richiedenti l’asilo» e di «profughi».
Profughi: né migranti né clandestini
Per rendere il dibattito costruttivo e comprensibile
all'opinione pubblica, bisognerebbe fare un tentativo di convergenza nell'uso
di termini appropriati ma non divisivi. Non mi sento di dire qual è
l’espressione più adeguata per indicare le masse che approdano sul litorale
italiano, ma la mia preferenza va al termine «profughi». Sebbene in
senso proprio «profugo» indichi specialmente chi è in qualche modo «costretto a
lasciare il proprio Paese in seguito a guerre, persecuzioni politiche, calamità
naturali, ecc.», in un senso più generale rende bene il senso della fuga (profugo
deriva dal latino profugum e dal verbo profugĕre, «cercare scampo») da una
situazione pericolosa o comunque precaria (ad esempio in seguito a carestia, fame,
mancanza di lavoro).
«Profugo» non è un termine divisivo ed è conosciuto e
accettato da tutti anche nel suo significato più generale, che può ben
comprendere tanto i migranti quanto i richiedenti l’asilo, i rifugiati e
persino i clandestini.
Trovo meno adeguato il termine «migranti», anche se è
quello che ha finito per imporsi, forse in ossequio all'uso che ne fa l’ONU
(quando parla dei «migranti internazionali»), perché l’«emigrazione» in Italia evoca
la condizione di chi era sì costretto ad espatriare «per motivi di lavoro», ma
emigrava perché c’era un Paese d’immigrazione disposto ad accoglierlo e a regolarizzarlo
(o addirittura lo richiedeva, come ad esempio la Svizzera nel dopoguerra). Allo
statuto di «migrante» erano generalmente collegati un regolare permesso di
lavoro e di soggiorno, una retribuzione corrispondente, ma anche la garanzia di
poter ritornare liberamente al Paese d’origine.
Del resto la condizione di «migrante» riguarda ancora oggi
decine di migliaia di italiani, che francamente hanno ben poco in comune con i
profughi che stanno giungendo in Italia soprattutto dall'Africa e dall'Asia. Anche
per i «migranti» italiani si tratta di cercare opportunità di lavoro altrove,
ma per essi questo avviene in condizioni completamente diverse, specialmente di
libera scelta e ampie garanzie.
In quest’ottica ho trovato fuorviante l’intervento della presidente
della Camera Laura Boldrini di un mese fa nel corso della presentazione
di un suo libro. Mentre criticava l’atteggiamento di chi continua a «considerare
la migrazione una minaccia» (con evidente riferimento al leader della Lega Matteo
Salvini, pur senza nominarlo) sbagliava a mio avviso nel confondere i
«migranti» (che vanno dove c’è la domanda, come ammetteva la stessa Boldrini,
contraddicendosi) con i profughi («che non vengono da noi per motivi economici
ma scappano dalle guerre»).
Ritengo invece che il termine «clandestini», preferito
da Salvini, sia completamente inadeguato perché nei profughi che sbarcano a
Lampedusa o in Sicilia non si può ravvisare l’intenzione della clandestinità e
sicuramente non riguarda la maggioranza di essi. Oltretutto la clandestinità
viene a cadere già al momento dello sbarco con la prima identificazione. Quanto
alle espressioni «richiedenti l’asilo» e «rifugiati», ritengo che debbano
essere riservate alle persone che possono avvalersi del diritto all'asilo e
ottenere lo statuto di rifugiato, non ad altre.
Manca la soluzione!
A questo punto non vorrei apparire come uno che riduce un
problema enorme a una semplice disputa terminologica. So infatti benissimo che
la soluzione va cercata principalmente al problema non alla disputa, ma sono
convinto che a seconda della scelta delle parole si può capire meglio il da
fare e svelare le ipocrisie. I «profughi» infatti hanno soprattutto bisogno di soccorso,
accoglienza, solidarietà, prima sistemazione. La problematica dei «migranti» è
invece molto più complessa perché ha bisogno soprattutto di una politica
immigratoria seria e coerente di cui non c’è alcun indizio né in Italia né nell’Unione
europea. Anche per questo, continuare a parlare di «migranti» da soccorrere mi
sembra un’ipocrisia.
Giovanni Longu
Berna, 22.4.2015 (scritto il 18.4.2015)
Berna, 22.4.2015 (scritto il 18.4.2015)
20 aprile 2015
Ancora morti nel "Mare nostrum"
Il Mediterraneo, che dal tempo dei romani chiamiamo «Mare nostrum», nei giorni scorsi ha interrotto violentemente la fuga di centinaia di profughi alla ricerca di una vita migliore. Erano, come ha detto domenica scorsa Papa Francesco, «uomini e donne come noi, fratelli nostri, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, che cercavano una vita migliore, cercavano la felicità».
 Non hanno fatto in tempo a goderne nemmeno
un poco perché il «Mare nostrum» li ha inghiottiti brutalmente per aggiungerli
alle migliaia di profughi già periti in questi ultimi anni. Non solo il
mare, ma anche i morti dovremmo considerare «nostri» e piangerli con qualche
senso di colpa.
Non hanno fatto in tempo a goderne nemmeno
un poco perché il «Mare nostrum» li ha inghiottiti brutalmente per aggiungerli
alle migliaia di profughi già periti in questi ultimi anni. Non solo il
mare, ma anche i morti dovremmo considerare «nostri» e piangerli con qualche
senso di colpa.
Sono morti perché il barcone sovraccarico
che li trasportava si è rovesciato, ma si trovavano su quel mezzo inadatto
anche per la cattiveria umana, per la nostra insensibilità e l’irresponsabilità
delle istituzioni competenti. Il nostro sentimento d’impotenza rischia di
diventare un alibi miserevole se non siamo capaci d’indignarci e reclamare a
gran voce dalle autorità responsabili soluzioni efficaci e sostenibili a lungo
termine.
Per non dimenticare i morti di ieri e di
oggi Piera Caponio ha scritto questa delicata poesia intitolata Vanno…,
«dedicata a tutti coloro che hanno
sognato una vita diversa, in un mondo diverso, con persone diverse. Ma hanno
perso».
Vanno…
Vanno,
inseguono un fragile sogno,
guidati da un lieve spiraglio.
Ombre furtive nel buio
li scrutano senza parlare,
mani rapaci si accostano,
carpiscono senza pietà.
L’ora che incalza li inghiotte,
procedono a passi guardinghi
sospinti da altri che vanno.
Audaci viandanti del nulla.
Son soli nel cuor della notte,
son soli col cuore che batte,
ma breve sarà la paura,
la luce è già là all’orizzonte…..
Si portano dentro una fiamma,
una fiamma che brucia e riscalda,
che guizza leggera e tenace
incontro al destino che avanza.
Poi d’improvviso uno schianto,
un bagliore scatena l’inferno,
le grida trafiggono il cielo
ma l’eco si perde nel nulla.
Son tonfi di corpi avvinghiati,
la fiamma pian piano si spegne,
il gigante pietoso li accoglie,
li copre con l’umido velo
e assorto riprende a cantare
l’ennesima sua ninna nanna.
Piera
Caponio
15 aprile 2015
Formazione e disoccupazione giovanile
L’Italia ha molti problemi, ma ve n’è uno in particolare che
dovrebbe preoccupare più di ogni altro quanti hanno responsabilità di governo:
la carenza di un’adeguata formazione professionale dei giovani. Eppure le conseguenze
sono disastrose e sotto gli occhi di tutti: in Italia oltre il 40% dei giovani
tra i 15 e i 24 anni è senza lavoro (il tasso di disoccupazione giovanile italiano
è quasi doppio della media europea).
So benissimo che nel breve periodo è quasi impossibile
raggiungere i tassi di due dei Paesi più virtuosi europei, la Germania e
la Svizzera (attorno al 7,5%), ma bisognerebbe almeno proporsi di
raggiungerli in un orizzonte temporale di medio periodo. Invece niente, a meno
che i guru dell’attuale governo non abbiano ritenuto sufficienti gli incentivi
all'occupazione giovanile (la cosiddetta «garanzia giovani») e il disegno di
legge di riforma della scuola, approdato da poco in Parlamento.
Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
La «garanzia giovani», un ambizioso progetto concepito e
finanziato in gran parte dall'Unione europea (UE), che prevede agevolazioni per
i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori in età dai 18
ai 29 anni, può servire certamente a dare un lavoro a un certo numero di
giovani disoccupati e a far diminuire di qualche punto il tasso di
disoccupazione giovanile, ma, come si vedrà meglio in seguito, non può essere
la soluzione risolutiva di questa piaga, che rischia di diventare cronica. Oltretutto,
non tutti i posti di lavoro possono essere occupati da giovani disoccupati, ma
solo se gli occupanti hanno i requisiti adatti.
E’ vero che i cospicui finanziamenti europei finalizzati a favorire
l’occupazione giovanile non sono destinati solo ad agevolare chi assume, ma
anche a sostenere programmi di orientamento, istruzione e formazione
professionale, formazione continua, apprendistati, corsi di perfezionamento. Ma
proprio sull'efficacia di questi programmi, per altro limitati nel tempo,
sorgono i maggiori dubbi. Non è infatti chiaro di che tipo di offerta si tratti
e quali caratteristiche debbano avere questi interventi riguardo a qualità,
durata, controlli, ecc.
Formazione professionale e disoccupazione
Quando poi si parla di formazione professionale il dubbio aumenta
perché con questa espressione non s’intende (più) il semplice e spesso abborracciato
avviamento al lavoro, ma un impegnativo processo di apprendimento teorico e
pratico di durata pluriennale, programmato e strutturato, che coinvolge l’ente
pubblico e l’economia, le parti sociali, la scuola, l’università, la ricerca,
l’innovazione, ecc. Non mi sembra che gli incentivi per la «garanzia giovani» riguardino
questo processo formativo. E allora? Allora la soluzione del problema va
cercata altrove e precisamente in una seria, moderna e sostenibile formazione dei
giovani.
.jpg) |
| Anche per molti italiani emigrati in Svizzera negli anni '60 e '70 la formazione professionale rappresentò il trampolino di lancio della carriera professionale (foto: allievi del CISAP, anni '80) |
Non occorre essere statistici o studiosi del settore per
rendersi conto che c’è una relazione molto stretta tra disoccupazione e
formazione e che i rischi della disoccupazione sono tanto maggiori quanto più
basso è il livello di formazione o quanto più inadeguata è la formazione
professionale. Se la disoccupazione giovanile sopra il 25% diventa cronica (e
la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia è sopra il 40%) i rischi per
il futuro dei diretti interessati ma anche del Paese sono enormi.
Penso che Matteo Renzi e il suo governo siano
consapevoli della gravità della disoccupazione giovanile, quasi da primato a
livello europeo, per cui non riesco a capire perché non abbiano ancora nemmeno
impostato un’autentica riforma della formazione dei giovani. So benissimo che in
questo campo le soluzioni non sono mai a portata di mano, ma proprio per questo
andava avviata fin dal discorso programmatico d’insediamento una seria
riflessione nel governo e nella società sul sistema scolastico italiano, non
più competitivo, e soprattutto sul sistema particolarmente carente della
formazione professionale.
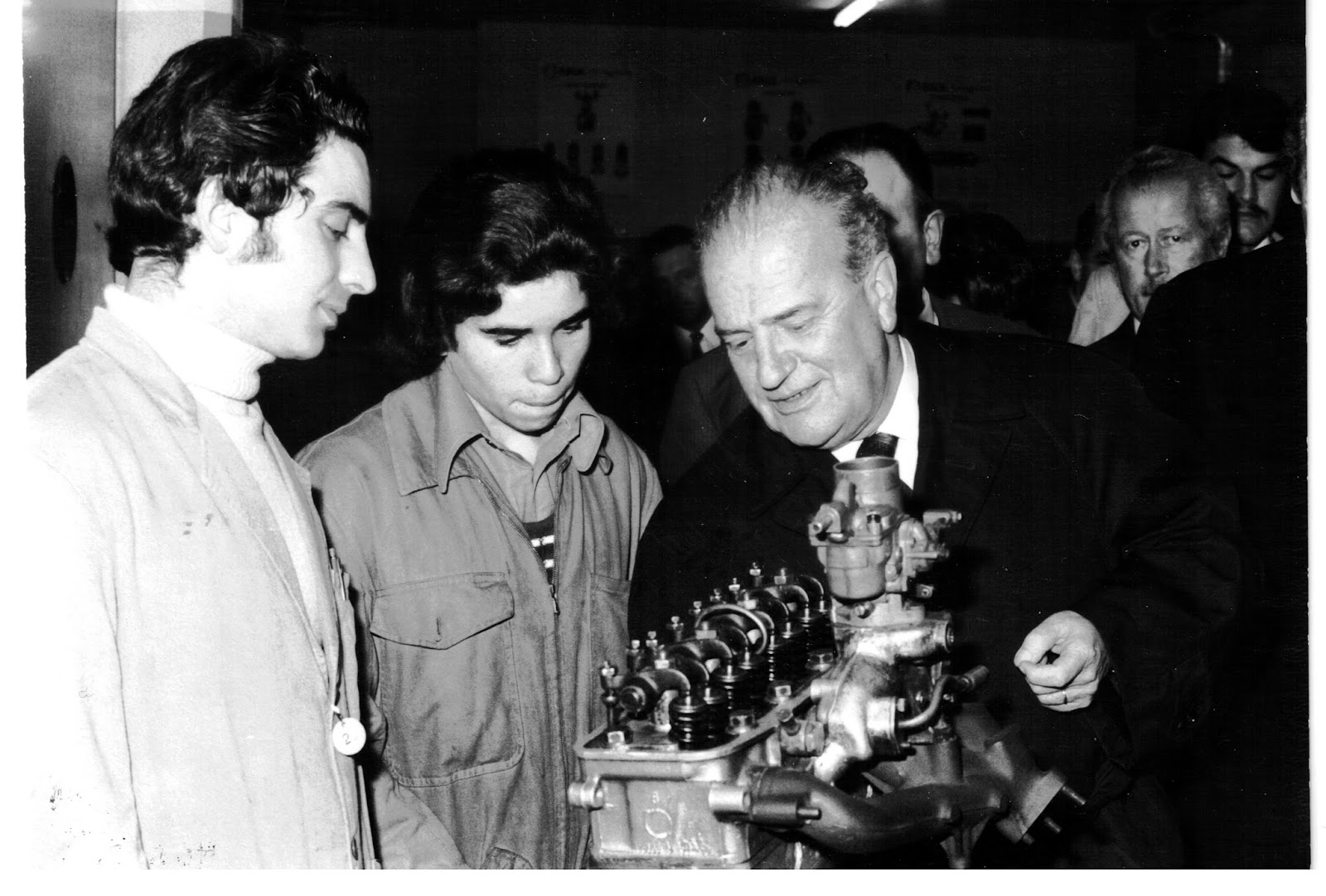 |
| Nel 1972 il pres. della Confederazione Nello Celio visitò con vivo interesse il centro di formazione professionale per lavoratori immigrati CISAP di Berna. |
Credo che l’Italia dovrebbe prendere esempio dai Paesi in
cui la disoccupazione giovanile è entro limiti «fisiologici» accettabili (ossia
da 1,5 a 2 volte superiore a quello della disoccupazione generale). A ben vedere,
in questi Paesi, specialmente Germania e Svizzera, la formazione professionale
è molto sviluppata e non a caso il numero dei giovani senza lavoro (o che non
studiano) è più ridotto che in Paesi, dove questa preparazione manca o è
carente. Una buona formazione (professionale) è sempre un antidoto efficace
contro la disoccupazione. Sebbene in situazioni di crisi si costati ovunque un
aumento delle difficoltà d’impiego, di solito in questi Paesi sono sufficienti
pochi interventi mirati per aiutare i giovani a trovare un posto di lavoro. E i
risultati si vedono.
Formazione professionale in Svizzera: un sistema che
funziona
Osservando più da vicino la situazione svizzera, non c’è
dubbio che la disoccupazione in generale e quella giovanile in particolare è
molto contenuta nel confronto internazionale proprio grazie a un sistema
consolidato di formazione professionale che accompagna i giovani dal termine
della scuola dell’obbligo al primo impiego e li segue anche dopo con la
formazione continua sempre più generalizzata.
Per comprendere meglio il sistema di formazione
professionale svizzero bisogna ricordare che è di tipo duale, ossia teorico (in
una scuola professionale) e pratico (presso un’azienda), e fornisce a due
giovani su tre una solida preparazione teorica e pratica corrispondente alle
esigenze del mondo del lavoro. L’efficacia di un tale sistema non si esaurisce
con l’acquisizione di un diploma o un certificato di capacità e l’avvio (quasi)
immediato al lavoro, ma continua anche in seguito durante tutta la vita
lavorativa. La formazione professionale costituisce infatti una solida base per
ulteriori perfezionamenti o specializzazioni fino ai massimi livelli della
ricerca (soprattutto nei politecnici) e della professionalità (nelle aziende) e
per la formazione permanente.
Data l’importanza evidente di questo sistema formativo, frutto
di un partenariato solido tra pubblico e privato, esso è costantemente
monitorato e aggiornato. Dev'essere infatti in grado di far fronte alle
esigenze dell’economia e della società in continua evoluzione. Un Paese come la
Svizzera, privo di materie prime, deve puntare necessariamente sull'alta
qualificazione delle risorse umane a tutti i livelli per garantire la
sostenibilità e la competitività del proprio sistema produttivo e il grado di
benessere raggiunto.
Ampio sostegno dello Stato e dell’economia
Per queste
ragioni, tanto l’economia pubblica e privata quanto i poteri pubblici
(Confederazione e Cantoni) attribuiscono grande importanza e i finanziamenti
necessari alla formazione professionale. La Confederazione, ad esempio, ne ha
fatto un apposito obiettivo quantificabile del programma di governo: «il
sistema di formazione professionale duale contribuisce a mantenere basso il
tasso di disoccupazione giovanile nel confronto internazionale». In
particolare, il governo si propone di sostenere «la formazione di giovani leve
in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell’economia» e
di migliorare «l’attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego».
 |
| Johann Schneider-Ammann |
Recentemente,
il ministro dell’economia Johann Schneider-Ammann ha affermato che in
futuro la percentuale dei giovani che dopo la scuola dell’obbligo continuano
una formazione scolastica o professionale deve essere aumentata al 95%.
Alla radice del sostegno incondizionato della Confederazione
a questo sistema di formazione professionale (simile per altro a quello della
Germania e dell’Austria) c’è una consapevolezza che è stata evidenziata l’anno
scorso dall’allora presidente della Confederazione Didier Burkhalter:
«Un Paese è una comunità di destini, la cui ragion d’essere sta nella capacità
di creare prospettive future. E la Svizzera ne è capace». L’esempio è dato
proprio dai giovani, la cui «buona formazione» permette loro di «accedere al
mondo del lavoro». Non solo, «il nostro Paese crea opportunità lavorative e
attira le giovani leve, non come in altre realtà, dove la disoccupazione è
altissima e i giovani sono costretti a migrare».
Italia: insufficienza formativa
Difficile escludere che tra le «altre realtà» Burkhalter non
pensasse anche all’Italia. Del resto è sotto gli occhi di tutti la gravità
della disoccupazione giovanile italiana, soprattutto nel Mezzogiorno. Proprio
per questo meraviglia che un governo dalle smisurate ambizioni come quello di
Renzi non faccia nulla per aggredire alla radice il male che rischia di
compromettere il futuro di un’intera generazione di giovani. Questo male si
chiama insufficienza formativa.
Sono note dalle classifiche internazionali le scarse
prestazioni degli alunni italiani della scuola dell’obbligo; il sistema
scolastico italiano è bocciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE); il sistema universitario italiano non riesce a
piazzare un ateneo tra i primi 100 al mondo (la Svizzera ne piazza ben
quattro); la ricerca scientifica è insufficiente nonostante alcuni centri di
eccellenza.
I rimedi finora proposti dal governo Renzi (e dai precedenti
governi) sono dei palliativi, non misure risolutive. La scuola avrebbe bisogno
di una profonda riforma strutturale (e non solo di facciata) per diventare
competitiva a livello europeo. Invece il disegno di legge presentato
recentemente dal governo è illusorio a cominciare dal titolo: «disegno di legge
sulla buona scuola». E illusoria è la presentazione che ne hanno fatto il presidente
Renzi e la ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania
Giannini, come pure il senatore del Pd Andrea Marcussi, presidente
della Commissione Cultura del Senato, parlando del disegno di legge come di una
svolta, anzi una «rivoluzione». Per rendersi conto di quanto invece sia
mediocre basterebbe leggere sul Corriere della Sera il commento
ragionato di Ernesto Galli della Loggia, intitolato «La scuola cattiva è
questa». Chi vuole può facilmente ritrovarlo in Internet.
Mancanza di volontà politica
Per realizzare in Italia una «buona scuola», fra l’altro,
occorrerebbe investire nel sistema scolastico molte più risorse di quelle
assegnate attualmente, che sono sotto la media dei Paesi dell’OCSE. Una «buona
scuola» sarebbe, inoltre, quella che «forma» mentalmente e culturalmente i
cittadini di domani, ma anche quella che prepara adeguatamente i lavoratori di
domani, in grado cioè di essere facilmente assorbiti, senza sussidi,
dall'economia.
Non credo che porre mano a una seria riforma della
formazione in Italia sia un’impresa impossibile e proprio per questo
bisognerebbe non perdere altro tempo per avviarla, ma dubito che la classe
politica attuale sia all'altezza del compito.
Giovanni Longu
Berna, 15.4.2015
Berna, 15.4.2015
01 aprile 2015
Euroscetticismo e xenofobia nell'UE e in Svizzera
Come in numerosi Paesi dell’Unione europea (UE), ad esempio,
Gran Bretagna, Francia, Italia, Austria, Grecia, anche in Svizzera sta
crescendo l'euroscetticismo. Ci sono ovviamente differenze importanti tra l’euroscetticismo
presente all'interno dell’UE e l'euroscetticismo osservato in Svizzera.
Euroscetticismo nei Paesi dell’UE
 L'euroscetticismo nei Paesi dell’UE nasce soprattutto dal
divario tra le intenzioni annunciate dagli organismi istituzionali e la realtà
percepita dai cittadini. Per esempio, sotto la presidenza italiana del
Consiglio UE (che intendeva far «cambiare la direzione di marcia dell’UE») le
parole chiave erano «crescita e occupazione», da attuarsi mediante riforme
strutturali, incentivi al lavoro, politiche di sostegno agli investimenti, una
politica monetaria flessibile. La realtà percepita dai cittadini è stata un
nulla di fatto. Le buone intenzioni non hanno prodotto risultati concreti. Basti
pensare che nel solo 2014 proprio dall’Italia sono espatriate oltre 100.000 persone
(di cui più di 11.000 in Svizzera). E’ dovuta intervenire, quest’anno, la Banca
centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona con l’acquisto
di massicce dosi di titoli di Stato.
L'euroscetticismo nei Paesi dell’UE nasce soprattutto dal
divario tra le intenzioni annunciate dagli organismi istituzionali e la realtà
percepita dai cittadini. Per esempio, sotto la presidenza italiana del
Consiglio UE (che intendeva far «cambiare la direzione di marcia dell’UE») le
parole chiave erano «crescita e occupazione», da attuarsi mediante riforme
strutturali, incentivi al lavoro, politiche di sostegno agli investimenti, una
politica monetaria flessibile. La realtà percepita dai cittadini è stata un
nulla di fatto. Le buone intenzioni non hanno prodotto risultati concreti. Basti
pensare che nel solo 2014 proprio dall’Italia sono espatriate oltre 100.000 persone
(di cui più di 11.000 in Svizzera). E’ dovuta intervenire, quest’anno, la Banca
centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona con l’acquisto
di massicce dosi di titoli di Stato.
Sulla scia della presidenza italiana, anche l’attuale presidenza
lettone ha indicato come priorità «il rilancio della competitività europea per la
crescita e la creazione di posti di lavoro», con l’aggiunta di dare all’UE una
vera dimensione internazionale. Altre belle parole che lasciano indifferenti gli
europei ancora alle prese, nonostante gli interventi della BCE, con la bassa
crescita, la disoccupazione, la crescente povertà, il degrado sociale di molte
periferie di città, l’emigrazione, l’irrisolta soluzione dei continui arrivi di
immigrati, disperati, profughi, ecc. A Bruxelles, dove hanno sede le principali
istituzioni europee, probabilmente non ci si rende conto del disagio sociale diffuso
in molti Paesi e delle aspettative deluse dei cittadini.
Euroscetticismo in Svizzera
Non è pertanto difficile capire perché in molti Paesi
dell’UE aumenti l'euroscetticismo. Resta invece da comprendere perché esso
cresca anche in Svizzera, che non fa parte dell’UE. Non si tratta a mio avviso
di una sorta di effetto contagio perché le relazioni con Bruxelles sono del
tutto diverse, anche se l’opinione pubblica svizzera è sicuramente influenzata
dalle reazioni osservate soprattutto in alcuni Paesi (ad es. Gran Bretagna,
Francia, Italia). Si tratta piuttosto di una reazione istintiva e irrazionale che
il popolo svizzero manifesta ogniqualvolta si sente in pericolo o sente
minacciati alcuni suoi diritti e valori fondamentali (libertà, sovranità,
democrazia diretta, ecc.).
In Svizzera l'euroscetticismo è soprattutto frutto di paura,
camuffata spesso con ragionamenti pseudo economici e pseudo valoriali. Per
esempio, con la libera circolazione delle persone molti svizzeri temono di essere prima o poi sopraffatti
dal forte afflusso di lavoratori provenienti dai Paesi dell’UE (anche da quelli
culturalmente più lontani) e di non essere più padroni a casa propria.
Le stesse persone evidentemente non considerano che dall'entrata in vigore (2002)
del relativo accordo bilaterale ad oggi non c’è stata alcuna immigrazione di
massa e che non ci potrebbe nemmeno essere se venisse a mancare l’offerta di
lavoro. Non solo, in tutti questi anni l’economia svizzera ha beneficiato
enormemente degli accordi con l’UE anche sulla libera circolazione.
Euroscetticismo e xenofobia
In Svizzera, come anche in altri Paesi dell'UE, l’euroscetticismo ha anche a che fare con la
xenofobia. Già in passato una
parte a volte molto consistente dell’opinione pubblica svizzera, di fronte a vere e
proprie ondate di immigrati (si pensi agli anni ’50, ’60 e ’70), ha temuto di
perdere il benessere raggiunto, la sicurezza del lavoro, la sicurezza sociale,
l’accessibilità all'abitazione, ecc., senza nemmeno chiedersi da dove
provenisse in fin dei conti quel benessere, la qualità della vita, la sicurezza
sociale. Senza l’immigrazione le attuali condizioni di benessere non ci sarebbero
state, né sarebbe possibile mantenerle in futuro senza di essa.
Un altro motivo dell’euroscetticismo è la confusione tra
immigrati e approfittatori. Siccome ci sono stati casi di stranieri giunti in
Svizzera per approfittare delle assicurazioni contro la disoccupazione,
l’invalidità, ecc. molti svizzeri ritengono che i lavoratori stranieri non
vengano solo per lavorare e contribuire ad accrescere il nostro benessere e la
nostra sicurezza sociale, ma per approfittare (per non dire rubare) delle
nostre assicurazioni sociali, della cassa malati, dell’assistenza sociale, ecc.
L’Europa è una garanzia per la Svizzera
Credo che alla radice dell’euroscetticismo, in Svizzera, ci
sia pertanto soprattutto una insufficiente conoscenza della storia,
dell’economia, dei rapporti globali con l’UE. Quanti sanno, ad esempio, che nel
1815 le grandi potenze europee garantirono la neutralità permanente della
Svizzera e l’inviolabilità del suo territorio? Quanti sanno che, oggi, un
franco su tre è guadagnato grazie agli scambi commerciali con l’UE (il 55%
delle esportazioni svizzere, pari a circa 116 miliardi di franchi nel 2013, è
diretto al mercato dell’UE)? E quanti si rendono conto che in una sorta di bilancio
i lavoratori stranieri ricevono complessivamente meno di quello che danno? E
quanti pensano che molto spesso la polemica con l’UE non è altro che una forma
di lotta interna tra partiti politici, tra Cantoni e Confederazione, tra
periferia e centro? Molti dimenticano inoltre con troppa facilità che l’Europa è
non solo la sede naturale della Svizzera, ma anche la garanzia di tutti i suoi
valori.
Giovanni Longu
Berna, 1 aprile 2015
25 marzo 2015
Nuovo accordo storico tra l’UE e la Svizzera
Le discussioni bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea
(UE) in alcuni momenti danno l’impressione di un dialogo fra sordi, nel senso
che ciascuna parte sembra voler mantenere ad ogni costo la propria posizione, come
se fosse inamovibile. Altre volte, invece, sembra che il dialogo avanzi, magari
a singhiozzo, segno che da entrambe le parti c’è la volontà di giungere il più
presto possibile, ma senza fretta (anche se per la Svizzera il tempo stringe),
se non ai risultati sperati da ciascuna parte almeno a un buon compromesso. E’
molto positivo che il dialogo continui, anche sui temi obiettivamente difficili
come quello sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE nel mercato del
lavoro svizzero.
Il dialogo continua
 Quest’anno il dialogo è ripreso ai massimi livelli con
l’incontro a Bruxelles tra la presidente della Confederazione Simonetta
Sommaruga e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker
(v. L’ECO del 18.3.2015) e sembra proseguire in un clima favorevole su svariati
temi. Alcuni segnali lasciano ben sperare.
Quest’anno il dialogo è ripreso ai massimi livelli con
l’incontro a Bruxelles tra la presidente della Confederazione Simonetta
Sommaruga e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker
(v. L’ECO del 18.3.2015) e sembra proseguire in un clima favorevole su svariati
temi. Alcuni segnali lasciano ben sperare.
Il 18 marzo 2015 sono
iniziati a Bruxelles tra il segretario di Stato Jacques de Watteville e
il direttore generale dell’UE Jonathan Faull i primi colloqui
esplorativi sulla fattibilità e l’opportunità di un accordo bilaterale
Svizzera-UE sui servizi finanziari. Sono pure in corso colloqui riguardanti un
miglioramento dell’accesso della Svizzera ai mercati dell’UE.
Il 19 marzo 2015 la Svizzera e l’UE hanno raggiunto un
accordo che prevede l’introduzione dello scambio automatico di informazioni
in materia fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 (anche se i primi scambi
avverranno effettivamente solo l’anno seguente).
Scambio delle informazioni fiscali
Questo accordo, anche se dovrà essere ancora sottoposto alle
Camere federali (ed eventualmente a referendum) per l’approvazione definitiva, segna
a mio avviso un punto di non ritorno nei rapporti non solo in materia fiscale
ma complessivi tra la Svizzera e l’Unione europea. Già, perché questo accordo è
stato fortemente voluto dall’UE, al fine di introdurre definitivamente nei
rapporti fiscali tra i cittadini dell’UE e la Svizzera la massima trasparenza
possibile. Mentre segna davvero la fine definitiva del segreto bancario
svizzero, non può non rappresentare il forte avvicinamento generale in tutti i
campi tra la Svizzera e l’UE.
Su questo accordo non ho letto in Svizzera molti commenti,
forse perché il tema è molto delicato e contrastato, ma non c’è dubbio che per
le relazioni con l’Europa esso rappresenta la rimozione di uno dei più grossi
ostacoli. Evidentemente gli svizzeri si aspettano ora qualcosa in cambio,
soprattutto nella direzione di una totale apertura dei mercati europei per le
imprese svizzere come pure per quel che riguarda la libera circolazione delle
persone.
«Accordo storico»
A sottolineare l’importanza dell’intesa raggiunta ci hanno
pensato i due negoziatori dell’accordo, il segretario di Stato Jacques de
Watteville e il direttore generale dell’UE Heinz Zourek. Il primo,
dopo aver siglato il documento sembra che abbia esclamato: «questo è un giorno
importante» e il secondo, visibilmente soddisfatto: « sono molto grato che
abbiamo trovato una risposta ad una questione politicamente e tecnicamente
difficile». Ma è stato lo stesso commissario europeo per la fiscalità Pierre
Moscovici, compiaciuto a sua volta del risultato raggiunto, a definirlo un
«accordo storico».
L’accordo raggiunto sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sostituisce il
precedente accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE in vigore dal 2005 e riguarderà,
una volta entrato in vigore, tutti i 28 Stati dell’UE e la Svizzera. L’accordo,
si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione federale, «è reciproco,
vale a dire che in caso di scambio di informazioni concernenti i conti gli
Stati membri dell’UE sottostanno agli stessi obblighi della Svizzera e
viceversa».
In questo accordo è stato
ripreso integralmente lo standard globale dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sullo scambio automatico di
informazioni, che è già stato alla base dell’intesa raggiunta tra la Svizzera e
l’Italia e che è ormai condiviso da un centinaio di Paesi e da tutte le
principali piazze finanziarie del mondo. La caduta del segreto bancario
svizzero non è pertanto opera di questo o quel ministro delle finanze o primo
ministro, ma il risultato di un processo a cui anche la Svizzera si è
sottoposta da tempo.
Ripercussioni per gli immigrati
Poiché il recente accordo siglato a Bruxelles riguarderà tutte
le relazioni finanziarie dei cittadini dell’UE e della Svizzera residenti
rispettivamente in Svizzera o in uno Stato dell’UE, è importante segnalare sin
d’ora ch’esso avrà ripercussioni anche sugli immigrati italiani in Svizzera.
Dal 1° gennaio 2017 (concretamente dal 1° gennaio 2018), infatti, tutti i dati
fiscali riguardanti i beni immobili e mobili (conti correnti, partecipazioni,
titoli azionari, ecc.) detenuti da essi in Italia saranno comunicati
automaticamente dall'
autorità fiscale italiana a quella svizzera. Viceversa,
l’autorità fiscale svizzera comunicherà a quella italiana tutti i dati fiscali riguardanti
i beni immobili e mobili detenuti in Svizzera appartenenti a residenti in
Italia.
Lo scambio automatico dei dati fiscali consentirà a ciascun
Paese quanto meno di ridurre l’evasione fiscale, ma non sarà certo questo
accordo a farla scomparire. Incentivare forme di autodenuncia, come stanno
facendo ora l’Italia e da tempo la Svizzera, dovrebbe favorire l’emersione dei
capitali nascosti al fisco e una maggiore equità fiscale fra i cittadini. E’
però auspicabile che gli Stati distribuiscano agli stessi cittadini le maggiori
entrate attraverso un riduzione mirata delle imposte.
Giovanni Longu
Berna, 25.03.2015
Berna, 25.03.2015
Svizzera: ripresa con moderato ottimismo
A pochi mesi dalla decisione della Banca nazionale svizzera (BNS)
di non più difendere a oltranza il tasso di cambio di 1,20 franchi per 1 euro,
politici, economisti e soprattutto industriali s’interrogano sul futuro
dell’economia svizzera se il franco dovesse ulteriormente rafforzarsi
sull'euro. Già la quasi parità attuale (1 euro vale 1,05 franchi) preoccupa non
poche aziende. E cosa accadrebbe, si chiedono in tanti, se il franco dovesse
superare la parità? Eppure numerosi segnali inducono a un moderato ottimismo.
Cresce la fiducia
Per molti imprenditori il cambio più facilmente sopportabile
sarebbe di 1,10 franchi per 1 euro, ma nessuno si fa illusioni, soprattutto
dopo la decisione della BNS, ribadita ancora nei giorni scorsi, di non più
sostenere artificialmente la moneta svizzera.
Quando fu dato l’annuncio, il 15 gennaio scorso, che la BNS
avrebbe posto fine alla difesa del franco con massicci acquisti di euro, molte
imprese furono prese dal panico. Si evocò persino lo tsunami prospettando una
catastrofe economica, l’aumento della disoccupazione, la recessione, la
diminuzione del PIL, ecc.
Oggi, nonostante si abbiano ancora pochi dati a disposizione,
si comincia a ragionare con più serenità e sono molti gli analisti fiduciosi
sulla capacità dell’economia svizzera di superare le difficoltà che
indubbiamente il superfranco pone, ma anche sul miglioramento della situazione
internazionale e specialmente dei grandi partner commerciali della Svizzera come
la Germania e gli Stati Uniti.
Secondo la BNS e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
nel 2015 non dovrebbe esserci recessione e il prodotto interno lordo
(PIL) continuerà a crescere, anche se a un ritmo nettamente inferiore rispetto
alle stime precedenti. La BNS prevede una crescita dell’1%, la SECO dello 0,9%.
Essa dovrebbe essere garantita sia dalla ripresa del consumo interno (ancora
sottotono nel quarto trimestre 2014) e sia dalle esportazioni.
Motivi di ottimismo
Questo ottimismo, per quanto prudente, lascia ben sperare in
un miglioramento del mercato del lavoro , che dovrebbe essere in grado
nel corso dell’anno di riassorbire una parte dei disoccupati degli anni
passati. Si spera che la tendenza alla crescita dell’occupazione, già osservata
nel quarto trimestre del 2014 prosegua o quantomeno non rallenti nel corso di
quest’anno.
Quanto alla disoccupazione, che non ha mai raggiunto
punti critici nemmeno nel periodo più acuto della crisi tra il 2008 e il 2010,
alcuni segnali la danno in diminuzione. Nel febbraio di quest’anno è
leggermente diminuita sia la disoccupazione generale (attestandosi attorno al
3,5%, con 136.764 disoccupati) che quella giovanile con poco più di 19.000
disoccupati (7,7%, ben al di sotto della media europea e persino al di sotto di
quella della Germania).
Si spera evidentemente che anche le esportazioni,
fondamentali per l’economia svizzera, tengano, pur senza illudersi che
possano raggiungere il record del 2014, quando il loro valore superò 208,3
miliardi di franchi e che la bilancia commerciale (differenza tra esportazioni
e importazioni) possa registrare nuovamente un surplus di oltre 30 miliardi di
franchi. Al riguardo non va nemmeno dimenticato che da tempo l’industria
svizzera punta sempre più sull’esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto
e questi, si sa, risentono generalmente meno delle fluttuazioni dei cambi
valutari.
Tra le principali ragioni del moderato ottimismo c’è anche una
fiducia diffusa sulla solidità dell’economia svizzera e delle sue imprese.
Negli anni scorsi, infatti, approfittando delle agevolazioni del cambio euro-franco
bloccato, sapendo che il sostegno della BNS sarebbe stato limitato al massimo a
tre anni, ossia fino all’inizio di quest’anno, molte imprese hanno approfittato
dei tassi d’interesse straordinariamente bassi per ristrutturarsi e consolidarsi,
in attesa di tempi migliori.
Alcuni osservatori fanno notare che l’ottimismo è più
evidente nelle imprese che nel frattempo si sono ristrutturate e preparate al
dopo crisi rispetto a quelle che non ne hanno approfittato per migliorare la
propria struttura interna (riorganizzazione e riduzione dei costi aziendali, aggiornamento
professionale del personale), adeguare l’offerta, rinnovare i prodotti. Queste
ultime, evidentemente, saranno le imprese maggiormente a rischio.
Il ruolo dello Stato
L’ottimismo, che si nota con sempre maggiore frequenza nei
media e nei comunicati ufficiali, dipende anche da un alto grado di fiducia degli
imprenditori svizzeri nell'efficienza di uno Stato liberale che si
preoccupa dei bisogni sia dei cittadini che dell’economia, che sa tenere i
conti in ordine, che si adopera per valorizzare le potenzialità del paese
attraverso un sistema di formazione (culturale e professionale) moderno, stimoli
alla ricerca e all'innovazione, il rispetto della democrazia e dei diritti
individuali. La fiducia nello Stato secondo molti imprenditori sarebbe ancora
maggiore se gli adempimenti burocratici fossero meno gravosi.
Viene spontaneo chiedersi a questo punto se anche altri
Paesi, magari confinanti con la Svizzera, con questi ingredienti potrebbero
guardare già al futuro prossimo, non a quello lontano, con altrettanto
ottimismo.
Giovanni Longu
Berna, 25.03.2015
Iscriviti a:
Post (Atom)


