Chi ha seguito gli articoli precedenti avrà sicuramente notato che alla base dei cambiamenti fondamentali riguardanti l’immigrazione italiana in Svizzera nel periodo in esame (1970-1990) c’era la spinta inarrestabile della «seconda generazione». Il fenomeno non era di per sé una novità assoluta, ma per la sua portata e complessità rappresentava per la Svizzera una sfida straordinaria che non era preparata ad affrontare. Poiché è stato tale da modificare radicalmente il corso della storia dell’immigrazione italiana in Svizzera, ad esso verranno dedicati alcuni articoli di approfondimento. Ovviamente non sarà possibile esaminare tutti gli aspetti del fenomeno, su cui esiste ormai una vasta letteratura, per cui ne verranno trattati solo alcuni ritenuti utili sia per accrescerne la conoscenza nei lettori interessati e sia per aiutare a capire l’influenza che la seconda generazione ha avuto non solo sulla componente italiana della popolazione straniera, ma anche sull'italianità della Svizzera.
Precisazioni necessarie
 |
| La scolarizzazione della seconda generazione ha creato non pochi problemi agli allievi, alle famiglie e alle istituzioni. |
ste erano abbastanza sovrapponibili, perché gli stranieri erano quasi tutti immigrati. Dagli anni Settanta in poi, invece, un numero crescente di stranieri non era più costituito da immigrati, ma da discendenti di immigrati.
I due gruppi, già di
per sé eterogenei per origine, età, formazione, ecc. vengono anche identificati
con le espressioni «prima generazione» (immigrati nati all'estero) e «seconda
generazione» (figli di immigrati, nati in Svizzera), ma non sempre riescono a
dare l’idea della consistenza e della diversità, anche perché ormai da tempo al
secondo anello della catena se ne stanno aggiungendo altri, la terza e
successive generazioni, e soprattutto perché un numero crescente di giovani
stranieri acquisisce la nazionalità svizzera. Un po’ di chiarezza è dunque
quanto mai opportuna: i figli
della seconda generazione non sono immigrati.
Le statistiche
svizzere, da cui sono attinti i principali dati usati in questi articoli, sono
in genere molto precise, perché distinguono chiaramente le diverse realtà,
focalizzando l’attenzione su aspetti particolari. Mentre tradizionalmente le
principali distinzioni demografiche si basavano sulla nazionalità e sul luogo
di nascita, da tempo l’Ufficio federale di statistica ha introdotto una
distinzione molto significativa basata sull'origine: «popolazione senza passato
migratorio» e «popolazione con un passato migratorio». In questo modo si riesce
ad evidenziare, per esempio, l’incidenza della «seconda generazione» rispetto
alla «prima generazione» nel secondo gruppo o la portata degli stranieri di
antiche origini (oltre la terza generazione) nel primo gruppo.
L’importanza di queste
distinzioni risulta evidente se si pensa che attualmente quasi il 38 per cento della popolazione residente di più di 15 anni
ha un passato migratorio e che di questo gruppo fanno parte ormai anche
molti svizzeri, perché più di
un terzo ha (anche) il passaporto svizzero e tende ad ampliarsi, sebbene la maggioranza (quasi due terzi) sia
ancora costituita da stranieri. Gli italiani costituiscono fin dal secondo
dopoguerra il gruppo più consistente della popolazione con un passato
migratorio e la seconda generazione, in forte crescita rispetto alla prima,
contribuisce a conservare questa posizione di punta e a rafforzare l’italianità
della Svizzera.
Quando nacque il problema?
Prima di analizzare
alcuni aspetti fondamentali della «seconda generazione» italiana del periodo in
esame, giova ricordare che fino alla seconda metà degli anni Sessanta essa non
aveva mai costituito un problema. La spiegazione è semplice: la prima ondata
immigratoria dalla fine della seconda guerra mondiale all'accordo
italo-svizzero d’immigrazione era costituita soprattutto da stagionali, per di
più sottoposti a un regime di «rotazione» che sembrava voler indicare
chiaramente che in Svizzera non ci si poteva fermare a lungo, tanto meno
tentare di metterci radici.
Accanto agli
stagionali, però, fin dall'immediato dopoguerra si venne a creare un nucleo
alimentato costantemente da nuovi arrivi di residenti
stabili. La sua crescita risultava anzi impressionante perché in dieci anni,
tra il 1950 e il 1960, gli italiani residenti (annuali e domiciliati) passarono
da 140.280 persone a 346.223. Ciò nonostante, il numero di figli di nazionalità
italiana nati negli anni Cinquanta è relativamente basso: circa 30.000 in tutto
il decennio.
Con l’arrivo in Svizzera, negli anni Sessanta, di centinaia di migliaia di immigrati, i nati italiani furono oltre 157.000, con un record di nascite nel 1969: 19.379. Non tutti questi bambini erano nati in Svizzera, perché molti erano giunti in età prescolastica dopo l’accordo italo-svizzero d’immigrazione del 1964, che aveva alleggerito le condizioni per i ricongiungimenti familiari. Nel 1970, come ricordato nell'articolo precedente, in Svizzera vennero censiti 151.625 piccoli italiani. La popolazione residente italiana era nel frattempo passata da 346.223 a 583.855. I problemi legati alla seconda generazione costituirono per tutto il decennio e oltre una vera emergenza.
Problemi a non finire
Oggi è persino scontato parlare della seconda
generazione degli italiani in Svizzera come di una grande risorsa che ha
contribuito a trasformare l’intero Paese e non solo la collettività italiana.
Per buona parte degli anni Settanta essa ha invece rappresentato una somma
considerevole di problemi a cui nessuna istituzione era in grado di offrire
soluzioni adeguate.
Oggi molti osservatori riconoscono nella
seconda generazione un buon esempio di integrazione riuscita e molti italiani
rimasti tali o naturalizzati si considerano ben integrati perché hanno potuto seguire una scolarità normale, hanno
appreso una buona professione e hanno raggiunto un tenore di vita
corrispondente alla media svizzera. Implicitamente si riconosce anche alla
Svizzera una grande capacità d’integrare i giovani stranieri, ma si dimentica
che fino ad allora le autorità svizzere non avevano mai pensato che l’immigrazione
potesse diventare da fenomeno temporaneo una condizione strutturale
dell’economia e della società.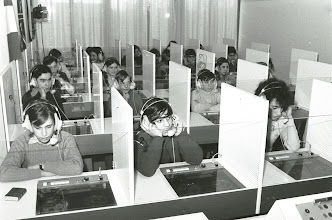
Per i bambini nati in Svizzera fu più facile superare le difficoltà linguistiche.
Agli inizi degli anni
Settanta dell’integrazione esisteva appena il nome, ma gliene veniva preferito
un altro, «assimilazione», perché le idee al riguardo non erano chiare, non
esistevano modelli da seguire, non esistevano istituzioni in grado di
occuparsene, non esisteva una politica d’integrazione. Esisteva solo una
richiesta precisa dell’Italia, formulata durante il negoziato sull'accordo
d’immigrazione del 1964, quella di facilitare
l’inserimento degli stranieri nella scuola locale.
Ma i problemi che poneva la seconda generazione degli italiani erano in realtà molti di più e alcuni anche molto gravi. Basti pensare al problema dell’«alloggio adeguato» dei genitori, come volevano le autorità svizzere, in un’epoca in
cui mancavano le abitazioni a
buon mercato ed era difficile produrle senza ricorrere a nuova manodopera
straniera, rischiando di suscitare i malumori degli ambienti xenofobi e di
contraddire la nuova politica immigratoria del Consiglio federale che mirava a
una riduzione e stabilizzazione della manodopera estera.
A mancare, in quel
periodo, non erano però solo le abitazioni adeguate per gli immigrati con
figli, ma anche le scuole materne, gli asili nido, l’edilizia scolastica, gli
insegnanti preparati ad accogliere i nuovi allievi portatori di nuovi problemi,
gli ospedali, ecc. Si sa che molte autorità comunali e
cantonali erano seriamente preoccupate, perché non riuscivano a trovare soluzioni
soddisfacenti.
I problemi sollevati dal fenomeno della
seconda generazione riguardavano, purtroppo, anche le stesse famiglie dei
piccoli italiani. E’ vero che, soprattutto
dopo l’accordo italo-svizzero, i genitori di questi bambini auspicavano per loro
una vita diversa da quella che avevano dovuto affrontare loro, ma molti di essi
esitavano persino a decidere se tornare in Italia o restare e quale scuola
seguire. E anche coloro che avevano deciso di restare, pensando soprattutto al
bene dei figli, spesso non erano in grado di fornire loro l’aiuto necessario a
superare le prime difficoltà linguistiche e scolastiche, a sostenerli nella
scelta scolastica e professionale, a favorirne l’integrazione sociale.
Benché i problemi posti
dalla seconda generazione soprattutto alle istituzioni svizzere fossero tanti e
di non facile soluzione, sarà interessante vedere come vennero superati, anche
se molte soluzioni richiesero molto tempo e molti sforzi. (Segue)
Giovanni Longu
Berna, 10.11.2021