90 anni fa l’Italia fascista aggrediva l’Etiopia per mania di grandezza imperiale e per trovare una destinazione sicura all'emigrazione. Non credo che questo anniversario sarà ricordato dai grandi media, specialmente in Italia. Per fortuna il tempo cancella molte ferite, ma non mi sembra privo d’interesse sia come fatto storico, legato fra l’altro alla politica migratoria del tempo, e sia come spunto di riflessione sull'attualità e soprattutto sui rischi che anche la nostra società può correre se non si percepisce il nazionalismo come una minaccia e non si riesce a produrre i necessari anticorpi per liberarcene. E’ vero che quell'aggressione è imputabile a una politica scellerata del fascismo, ma non si può ignorare che a renderla accettabile anche da moltissimi immigrati, furono un diffuso nazionalismo, carenze democratiche e indifferenza sociale. Purtroppo il nazionalismo è nuovamente in crescita in Europa e anche in Italia e si fa poco per denunciarne la pericolosità. La corsa al riarmo, la bassa considerazione degli immigrati e dei diritti umani e lo scarso impegno per «lo sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo solidale dell’umanità» (Paolo VI nell'enciclica Populorum progressio del 1967) non promettono nulla di buono. Dovremmo reagire tutti.
I fatti in breve
L’invasione dell’Etiopia
rientrava in questa politica, senza rendersi conto dei rischi. Le operazioni
militari si svolsero fra il 3 ottobre
1935 e il 5 maggio 1936, a partire dalle colonie italiane d’Eritrea e Somalia.
Mussolini era convinto che la potenza di una nazione dipendesse dal suo impero
coloniale, pur sapendo che i territori più vantaggiosi erano già occupati. Volle
ugualmente la conquista di un Paese arretrato e male armato come era allora
l’Etiopia, convinto «che ormai gli fosse tutto possibile usando la
forza» e una rapida vittoria fosse alla sua portata. La campagna d’Etiopia fu
un’interminabile strage con centinaia di migliaia di morti militari e civili,
attuata con bombardamenti massicci, l'impiego di armi chimiche e la repressione
contro la popolazione etiope.
Dopo qualche momento di esitazione, a causa degli accordi di
mutua convenienza sanciti dai Patti Lateranensi (1929) e della posizione del
clero italiano, che appoggiava in gran parte la guerra, il papa Pio XI
intervenne decisamente il 28 agosto 1935 dichiarando che «una guerra condotta
unicamente per conquistare era una guerra ingiusta: qualcosa di indicibilmente
triste ed orrenda”. Mussolini non lo ascoltò, ma non altrettanto fecero altre
potenze che investirono del caso la Società delle Nazioni (SdN), antesignana
dell’ONU. E questa decise severe sanzioni contro l’Italia, a cui aderì anche la
neutrale Svizzera.
Le reazioni tra gli emigrati
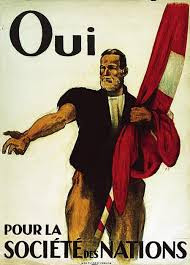 |
| Manifesto in vista della votazione del 16.5.1920 sull'adesione svizzera alla Società delle Nazioni (Biblioteca nazionale svizzera, Berna). |
In Svizzera non ci fu una reazione omogenea perché, come si
è visto negli articoli precedenti, l’antifascismo aveva cominciato a far presa
su gruppi organizzati già dagli anni Venti e sul solido gruppo socialista di Zurigo che faceva riferimento al «Cooperativo». Per questo l’aggressione
dell’Italia all'Etiopia tra gli immigrati italiani non è stata particolarmente
seguita, anche per il tiepido atteggiamento governativo svizzero.
Al riguardo desidero ricordare che la reazione della
Confederazione alle decisioni della Società delle Nazioni è stata alquanto
singolare. Infatti, pur aderendo in quanto Stato membro, alle sanzioni della
SdN, decise di non applicarle rigidamente nei confronti dell’Italia, ritenuta
un «Paese amico». Al consigliere federale Giuseppe
Motta, capo della politica estera, più della fedeltà al Patto della
SdN interessava la difesa della neutralità della Svizzera e soprattutto degli
interessi economici in Italia (si pensi al problema degli approvvigionamenti).
Di fatto, la Svizzera finì per adottare le sanzioni contro l’Italia solo in
misura molto blanda, quasi simbolica. Non solo, nel dicembre del 1936 la
Svizzera, su proposta di Motta al Consiglio federale, fu il primo Paese neutrale
a riconoscere ufficialmente l’Impero italiano in Africa e a considerarne i suoi
abitanti nel contesto del Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e
Italia del 1868.
In conclusione
Oggi rievoco quella tragica aggressione, in cui i soldati
italiani del Ventennio si macchiarono di atroci delitti, non solo come un fatto
storico che ha influito sull'emigrazione italiana nel mondo, ma anche per
denunciare che il fascismo aveva talmente contagiato il mondo degli emigrati
italiani organizzati da far pensare che bastasse una vittoria militare, per
altro immeritata data l’evidente differenza della preparazione degli eserciti
contrapposti, per far dimenticare le umiliazioni subite nel Paese d’immigrazione.
Purtroppo molti non si rendevano conto che solo una buona integrazione e uno
sforzo di solidarietà collettiva li avrebbe parificati agli autoctoni.
Ricordare l’aggressione italiana dell’Etiopia, che all'epoca
suscitò tra gli emigrati grandi entusiasmi un po’ ovunque, vuol essere anche un
richiamo alle responsabilità individuali per evitare che il nazionalismo, anche
in forme apparentemente innocue, possa produrre in futuro danni enormi e un
invito a diffidare di forme ambigue e pericolose di deterrenza, perché la corsa
al riarmo di oggi non promette nulla di buono e non mi sembra saggio invocare la
pace preparando la guerra.
Giovanni Longu
Berna 9 luglio 2025



















