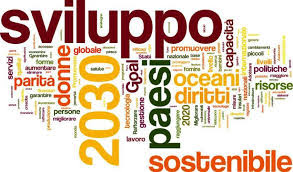Dire che la società è in continua trasformazione è banale
perché si tratta di un’evidenza. Anche sostenere, come fanno alcuni politici
italiani, che l’attuale governo sia quello del cambiamento è una banalità,
perché tutti i governi sono in qualche misura diversi dai precedenti. Per aver
senso tali affermazioni dovrebbero indicare la direzione del cambiamento. In
altre parole, gli atti della nuova maggioranza parlamentare e le iniziative del
governo dovrebbero fornire indicazioni plausibili sul futuro del Paese, della
società, dell’economia, dei giovani, del bene comune. Francamente, fino a
questo momento, nessun segnale mi sembra rassicurante e incoraggiante.
Situazione di partenza difficile

Il debito pubblico italiano è uno dei più alti del mondo in
cifre assolute e relative alla popolazione. Per l’Italia è una situazione di
partenza difficile, soprattutto se si tiene conto di altri elementi storici,
geografici, economici, culturali e sociali che pesano sulle prospettive di
sviluppo sostenibile. Basti pensare al divario nord-sud, ricchi e poveri, occupati e disoccupati. Una delle
caratteristiche degli elementi che trovo maggiormente preoccupanti dell’azione
del governo a guida
Giuseppe Conte è la disinvoltura con cui sembra
sottovalutare sia il debito pubblico che alcuni elementi negativi, quali la
scarsa crescita, la forte evasione fiscale, la corruzione, l’aumento della
povertà, la rassegnazione di molti cittadini.
Quanto al debito, anche i bambini sanno che prima o poi si deve paga. I debiti nazionali li pagano i cittadini con nuove
tasse o nuove privazioni e le future generazioni con una diminuzione della
qualità di vita. Ciononostante, il Governo ha approvato la settimana scorsa una
manovra di bilancio in deficit, ossia aumentando il debito che graverà
soprattutto sulle generazioni future.
Approvare una tale manovra con la certezza di appesantire
ulteriormente il debito pubblico e di portare il deficit al 2,4% del PIL
(prodotto interno lordo), invece di mantenerlo al di sotto del 2,0% per consentire la
riduzione del debito, è apparso a molti osservatori nazionali e internazionali
un azzardo insensato. Uno dei quotidiani più prestigiosi della Svizzera
titolava un commento al riguardo: «Trionfo dell’insensatezza a Roma: l’Italia
vuol fare ulteriori debiti» (NZZ).
Pur ammettendo che il debito pesa soprattutto quando lo si
deve pagare, è evidente che può cominciare a pesare già prima se i mercati
reagiscono negativamente (come successo venerdì scorso) o qualora si chiedesse
un prestito alle banche per finanziare una casa o un’attività economica. Trovo
assolutamente insostenibile che alcune iniziative si finanzino facendo
ulteriori debiti invece che riducendo gli sprechi o recuperando l’evaso a costo
zero (senza condoni).
Insostenibilità della manovra in deficit
Uno degli indicatori della sostenibilità dello sviluppo
economico di un Paese è la preservazione del capitale. Ma se il capitale
disponibile viene ridotto oggi, per investimenti insostenibili (reddito di
cittadinanza, pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero, flat
tax, «pace fiscale», ecc.), chi garantirà ai nostri figli e nipoti le
risorse necessarie per il loro benessere? Con quale senso di responsabilità si
mette a repentaglio la qualità di vita delle future generazioni, se in Italia
il tasso di rischio di povertà (11,1%), in percentuale su tutti gli occupati, è
già oggi nettamente superiore a quello medio dell’Unione Europea (9,6%)?
Tutte le misure insostenibili peseranno sulla qualità di
vita dei nostri figli e nipoti perché avranno a disposizione meno risorse
ambientali, economiche e sociali. Incurante delle reazioni delle opposizioni,
dei mercati, di alcuni esponenti dell’Unione Europea (UE), il premier Conte osa
affermare di aver approvato la «manovra del popolo» e con essa «
il
più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in
Italia». Crederlo sulla parola? No, preferisco giudicare sui fatti e
comunque attendere, presto, il giudizio definitivo della Commissione europea,
anche se qualche anticipazione c’è già stata: «
Quello che emerge finora
dalla discussione in Italia non sembra in linea col patto di stabilità. È
importante che l’Italia si attenga a politiche di bilancio responsabili per tenere
i tassi bassi» (Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE).
Spero, ovviamente, che l’Italia risalga presto la china,
riprenda la sua corsa in Europa, dia speranza soprattutto ai più colpiti dalla
crisi, i poveri, i disoccupati e i giovani. Ma alcuni segnali mi preoccupano,
soprattutto la rassegnazione diffusa in quasi tutti i ceti sociali e la
politica immigratoria. Forse è utile per capire la direzione che sta prendendo
o dovrebbe prendere l’Italia del cambiamento conoscere meglio alcuni aspetti
della situazione italiana.
Stato della popolazione
a)
Popolazione
La popolazione italiana di poco più di 60 milioni di persone invecchia più
velocemente di qualsiasi altra popolazione europea. Se l’incremento naturale
ogni 1000 abitanti era di 1,5, nel 2017 è di -3,1(!). Si sa che
l’invecchiamento eccessivo comporta numerosi problemi alla società nel suo
insieme e soprattutto ai giovani. In molti Paesi, per evitare che il tasso di
dipendenza dei minorenni e degli anziani dalle persone in età dai 14 ai 64 anni
diventi insostenibile, si attua una sana politica d’integrazione degli
stranieri. L’Italia sembra preferire la soluzione di questo problema tramite
badanti.
b)
Incremento naturale della
popolazione
L’Italia è il Paese con un tasso di fecondità (numero di figli per donna) tra i più bassi in
Europa e nel mondo, nel 2017: 1,3 figli per donna (CH: 1,5; DE: 1,6; F: 2,0).
Anche il tasso di natalità ogni 1000 abitanti è tra i più bassi in Europa e nel
mondo: 7,6 (CH: 10,3; DE: 9,5; F: 11,4). Inoltre, la tendenza al matrimonio
scarseggia. Il numero dei matrimoni ogni 1000 abitanti è tra i più bassi
d’Europa: 3,4 (CH: 4,8; DE: 5,0; F: 3,5). Ossia, l’incremento naturale è
manifestamente a rischio.
c)
Saldo migratorio
Il saldo migratorio è la differenza tra il numero degli immigrati e
quello degli emigrati. In Italia è stato sempre basso (1980: 0,1, contro il 2,7
della Svizzera e il 3,9 della Germania) e, contrariamente a molta
disinformazione assai diffusa, resta ancora molto basso (2017: 1,4, contro il
5,4 e il 5,8 rispettivamente della Svizzera e della Germania).
d)
Formazione dei giovani
I giovani italiani tra i 18 e 24 anni senza una formazione post
obbligatoria (31,7% nel 2016) è ben superiore alla media europea (26,1%). Gli
adulti (25-64 anni) con formazione superiore (17,7%) sono nettamente sotto la
media europea (30,7%). Nella manovra economica appena approvata il
Governo avrebbe potuto destinare risorse consistenti per la scuola, la
formazione, la ricerca, l’università. Non l’ha fatto scegliendo altre priorità demagogico-elettorali.
Peccato per l’Italia, un tempo grande potenza economica e culturale, e oggi non ha nemmeno
un’università tra le prime 100 della classifica mondiale (la piccola Svizzera,
tanto per un confronto, ne colloca ben cinque!)
Italia rassegnata
Alla luce anche di questi dati statistici, ho trovato
comprensibile, durante un recente viaggio in Italia, la rassegnazione di molta
gente, di tutte le classi sociali, sulla situazione italiana. Nessuna delle
persone incontrate ha palesato soddisfazione, tutte mi hanno confermato il
clima di rassegnazione diffuso da nord a sud e la speranza di molti giovani di
trovare lavoro all’estero. Non mi sono addentrato sulle cause di tanta
rassegnazione, perché le risposte sarebbero state molto probabilmente monotone:
«non c’è lavoro, soprattutto per i giovani», «non ci sono programmi
d’occupazione»… e simili.
Peccato! Perché conservo nella memoria sedimentata ormai da
decenni l’immagine di un’Italia laboriosa, ambiziosa, combattiva, anche con
molti scioperi, niente affatto rassegnata alla povertà, alle ingiustizie
sociali, alla disoccupazione. Era anche un’Italia molto contrastata perché
pervasa da ideologie antagoniste incarnate in partiti politici e sindacati
contrapposti, che avevano però in comune l’ambizione del lavoro per tutti,
della dignità dei lavoratori, dell’accesso allo studio e della ricompensa
sociale. Se è vero che oggi l’Italia è un Paese rassegnato e che le ideologie
sono morte, la situazione diventa critica perché lascia spazio alla delega in
bianco, al populismo, all’autoritarismo.
L’immigrazione
Sull’immigrazione, intesa in tutte le sue forme, ho trovato
una sorta di accettazione senza resistenza della politica del ministro Salvini,
perché nello stato in cui si trova oggi l’Italia nessuna istituzione sembra in
grado di accogliere numeri consistenti d’immigrati, formarli e inserirli nel
mondo del lavoro. La paura dello straniero si diffonde, senza che nessuno
cerchi di spiegare che è totalmente priva di fondamento (non esiste alcun dato
storico di popoli sopraffatti da immigrati pacifici) e serva soprattutto a
nascondere l’incapacità del governo a gestire il fenomeno migratorio. Tant’è
che manca in Italia, a quanto ho potuto notare, una politica immigratoria degna
di questo nome, con obiettivi precisi, strutture adeguate, programmi, forme di
accompagnamento.
Di fronte alle critiche piovute da ogni parte all’Italia per
l’atteggiamento nei confronti dei profughi, il Presidente del Consiglio Conte
ribatte che la politica italiana verso gli immigrati «ha al primo posto
l’obiettivo di tutelare la dignità delle persone, salvare le vite e difendere i
diritti fondamentali delle persone». Che faccia!, verrebbe da dire, anche alla
luce delle critiche che continuano ad arrivare alla politica migratoria
italiana per l’atteggiamento cinico del ministro dell’Interno Matteo Salvini
nei confronti dei migranti, delle ONG, delle associazioni umanitarie, ecc.
Salvini, ministro dell’Interno, è diventato in quattro mesi
l’uomo forte del governo. E’ riuscito persino a far rientrare la questione dei
migranti nelle sue competenze e a trattarla come un problema di ordine
pubblico. Il decreto sicurezza approvato
dal governo prevede infatti misure severe per i migranti, come l’abolizione
della protezione internazionale per i migranti in caso di condanna in primo
grado, ecc.
Personalmente trovo preoccupante che in Italia, patria di
civiltà, si finisca per considerare i migranti potenziali criminali pericolosi,
quasi da sorvegliare a vista. Preoccupante anche come un ministro della
Repubblica si difenda dalle accuse rivolte ad alcuni suoi provvedimenti: «Faccio ciò che mi hanno chiesto gli italiani… sono gli
italiani che mi pagano». Non credo che il popolo italiano gli abbia affidato il
compito di condurlo all’isolamento internazionale, al progressivo impoverimento,
al benessere effimero perché a breve termine ma certamente insostenibile a
lungo termine.
Giovanni Longu
Berna, 2 ottobre 2018