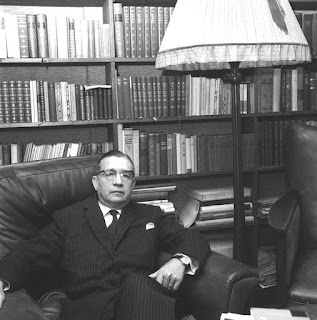Sul finire degli
anni Sessanta la politica immigratoria era talmente discussa in pubblico e in
privato che il partito di Schwarzenbach, l’Azione Nazionale (AN), riuscì
facilmente a raccogliere in tutta la Svizzera un numero ben più ampio del
necessario a sostegno della sua seconda iniziativa contro
l’«inforestierimento». L’immigrazione era considerata per la prima volta un
«problema» nazionale che andava risolto decisamente. Agli occhi dei sostenitori
di una politica restrittiva verso gli stranieri Schwarzenbach sembrava l’uomo
giusto al momento giusto: colto, editore e scrittore, ricco (proveniente da una
famiglia di industriali), anticomunista, a suo modo un vero combattente «contro
i poteri forti», come si direbbe oggi, specialmente la grande industria, perché
convinto che uno sviluppo economico fondato sulla manodopera estera a buon
mercato fosse scriteriato e insostenibile.
L’iniziativa Schwarzenbach
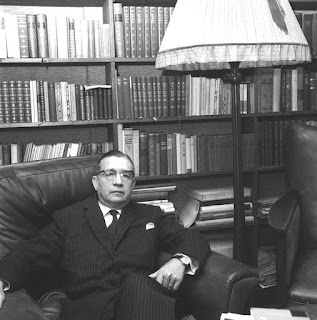 |
| James Schweizer (Keystone/Str) |
Nonostante gli interventi del Consiglio federale per ridurre
l’immigrazione, era sotto gli occhi di tutti che la popolazione straniera non
faceva che aumentare. Per l’AN, che aveva appena ritirato la prima iniziativa
antistranieri (1968), non c’era tempo da perdere, tanto più che aveva trovato
nel suo neoconsigliere nazionale James Schwarzenbach (1911-1994) la persona
forse più convinta per sostenere una nuova iniziativa popolare ancor più
radicale di quella appena ritirata. In effetti, in poco tempo furono raccolte a
sostegno ben 70.292 firme valide (quando ne sarebbero bastate 50.000) e il 20
maggio 1969 l’«
iniziativa Schwarzenbach» fu depositata alla Cancelleria
federale. Il Consiglio federale decise di porla in votazione il 7 giugno 1970
proponendone il rigetto, come aveva deciso anche l’Assemblea federale
(Parlamento).
All’infuori dell’AN, nessun altro partito politico, nessun
sindacato, nessuna chiesa, nessuna organizzazione economica e nessun’altra
organizzazione erano favorevoli all’iniziativa.
E’ possibile che il suo
principale sostenitore, Schwarzenbach, provasse una sorta di esaltazione nel sentirsi
come un piccolo Davide a lottare contro un enorme Golia costituito dall’establishment non solo politico, ma
anche mediatico, religioso e soprattutto economico. Partecipò a innumerevoli
dibattiti, era convinto di trovarsi dalla parte giusta e le critiche non
scalfivano la sua motivazione profonda di doversi battere in quanto svizzero
per gli interessi del suo Paese.
Incertezza e paura
Nei giorni precedenti la votazione popolare a dominare i
sentimenti tanto degli svizzeri che degli stranieri erano soprattutto
l’incertezza e la paura. Tutti i pronostici della vigilia davano uno scarto di
voti tra i sì e i no esiguo, ma nessun sondaggio dava per scontata la vittoria
dei sostenitori o dei contrari.
L’incertezza era data anzitutto da quanti sarebbero andati a
votare, perché la complessità dell’iniziativa avrebbe potuto scoraggiare la
partecipazione. Essa chiedeva infatti non solo la riduzione della componente
straniera in ogni Cantone al 10% dei cittadini svizzeri (25% nel Cantone di Ginevra),
entro quattro anni, ma anche «provvedimenti per lottare contro
l’inforestierimento demografico ed economico della Svizzera» e la protezione
dei cittadini svizzeri contro il licenziamento «per motivi di razionalizzazione
o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda o
nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri». Per
evitare che il Governo adottasse provvedimenti straordinari di
naturalizzazione, al fine di ridurre il numero degli stranieri residenti,
l’iniziativa consentiva al Consiglio federale unicamente la «naturalizzazione
agevolata» dei figli nati da padre straniero e da madre «cittadina svizzera per
origine», purché i genitori avessero avuto il loro domicilio in Svizzera al
tempo della nascita dei figli.
 |
| Manifesti contro e pro l’iniziativa Schwarzenbach |
L’incertezza maggiore era dovuta però soprattutto alla
scelta di voto dei partecipanti, perché dai dibattiti era emerso che in caso di
accettazione dell’iniziativa a pagarne le conseguenze economiche e sociali sarebbero
stati non solo gli stranieri costretti a lasciare la Svizzera, ma anche molti
svizzeri, che non avrebbero potuto supplire alla mancanza dei partenti. Anche
per questa ragione la campagna a favore e contro l’iniziativa di Schwarzenbach fu
molto accesa tra i politici e nella popolazione.
L’iniziativa, per quanto complessa, era assolutamente chiara
su un punto: se fosse stata accolta dal Popolo svizzero, entro quattro anni una
parte consistente di stranieri, allora soprattutto italiani, avrebbe dovuto
lasciare la Svizzera anche se in possesso del permesso di domicilio. Secondo i
calcoli del Consiglio federale, se l’iniziativa fosse stata accolta dal popolo
svizzero e dalla maggioranza dei Cantoni, sarebbero stati almeno 310.000 gli stranieri
costretti ad andar via. La quota a carico degli italiani sarebbe stata
preponderante. Il sentimento che si diffuse tra loro nei mesi e nelle settimane
prima della votazione fu soprattutto di paura, perché nessuno si riteneva più
al sicuro, nemmeno i domiciliati, soprattutto in quei Cantoni dove gli
stranieri superavano il 10%.
L’esito della votazione
L’iniziativa Schwarzenbach fu votata il 7 giugno 1970.
Quella votazione resterà negli annali della democrazia svizzera perché vide una
partecipazione record del 74,7% dell’elettorato (allora solo maschile perché il
suffragio femminile sarà introdotto solo nel 1971), inferiore solo a quella
(79,7%) sull’introduzione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) nel
1947, ma mai più superata in seguito. Il perché di tanta partecipazione fu la
posta in gioco, che come già ricordato, concerneva non solo gli stranieri ma
anche moltissimi svizzeri.
La maggioranza del popolo svizzero (654.844 voti contrari
pari al 54% dei votanti e 557.517 favorevoli, 46%) e 13 Cantoni più 4
Semicantoni (contro 6 Cantoni e 2 Semicantoni) respinsero l’iniziativa, ma fu
una sorpresa l’alta percentuale di sì in tutta la Svizzera.
I Cantoni e Semicantoni che respinsero l’iniziativa sono
stati: Zurigo (56,4% di no), Glarona (53,5%), Zugo (52,2%), Basilea Città (53,3%),
Basilea Campagna (60,5%), Sciaffusa (59,7%), Appenzello Esterno (57,1%),
Appenzello Interno (50,3%), San Gallo (53,9), Grigioni (59,5%), Argovia (52,5%),
Turgovia (59,4%), Ticino (63,7%), Vaud (58,7%), Vallese (54,0%), Neuchâtel
(60,9%), Ginevra (60,3). Approvarono invece l’iniziativa i Cantoni e
Semicantoni di: Uri (63,3%), Nidvaldo (55,7%), Lucerna (54,6%), Obvaldo
(54,5%), Svitto (52,6%), Berna (52,1%), Soletta (51,4%), Friburgo (50,3%).
Si attribuì il rigetto dell’iniziativa solo alla paura delle
imprevedibili conseguenze che avrebbe comportato una sua accettazione, sia per
il clima sociale che avrebbe inevitabilmente surriscaldato e sia per le
negative previsioni sull’economia. Poiché la misura del 10% si sarebbe dovuta
applicare in ciascun Cantone, nei Cantoni con una percentuale di stranieri
inferiore al 10% (alcuni piccoli Cantoni e quelli poco industrializzati)
l’iniziativa non avrebbe comportato alcun cambiamento, mentre nei Cantoni molto
industrializzati avrebbe potuto procurare danni enormi alla produzione
industriale e al clima sociale.
Inforestierimento come pretesto?
Un’altra considerazione merita di essere presentata ed è che
la densità di stranieri ha influito poco o niente sull’esito della votazione.
Infatti l’iniziativa è stata accolta soprattutto nei Cantoni contadini dove la
percentuale di stranieri era relativamente bassa (Berna, Friburgo, Soletta,
Lucerna, ecc.), mentre è stata respinta nei Cantoni industriali e in quelli
periferici dove la percentuale era relativamente alta (Zurigo, Basilea Città e
Basilea Campagna, Ticino, Grigioni, Neuchâtel, Ginevra, ecc.). Come a dire che
a prevalere, in questo tipo di votazioni, sono gli interessi economici più che
le ideologie.
Si deve dunque dedurre che la paura dell’inforestierimento è
stata solo un pretesto usato da Schwarzenbach per contestare un certo sistema
capitalistico-liberale dell’economia, disposto apparentemente a sacrificare
tutto in nome dello sviluppo e del profitto, addossando allo Stato tutte le
conseguenze politico-sociali? La domanda è legittima come è altrettanto legittima
la seguente: nella sua lotta senza quartiere contro la grande industria e la
politica federale che a suo dire permetteva che decine di migliaia di stranieri
venissero sfruttati, Schwarzenbach si rendeva conto che se la sua iniziativa fosse
stata approvata dal Popolo e dai Cantoni avrebbe procurato danni rilevanti a
decine di migliaia di famiglie, soprattutto italiane, ma anche svizzere? Non
sarebbe stato più onesto mirare a colpire il governo federale e la sua politica
ritenuta troppo lassista nei confronti del capitalismo, invece di coinvolgere
drammaticamente migliaia di lavoratori immigrati e le loro famiglie del tutto
estranei ai giochi di potere?
Le risposte non possono essere sbrigative per cui vengono
rimandate al prossimo articolo, ma si può già anticipare che l’«iniziativa
Schwarzenbach», per i toni della polemica, ma anche per l’esito finale, ha
contribuito in misura determinante a cambiare la storia dell’immigrazione
italiana in Svizzera. (Segue)
Giovanni Longu
Berna, 18.09.2019
 In realtà, da molto
tempo gli scienziati lanciano l’allarme sui rischi di un eccessivo e
sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sul
riscaldamento del pianeta, ecc. Ricordo di essere stato profondamente
impressionato da una conferenza promossa dal Club di Roma a Berna agli inizi degli
anni Settanta del secolo scorso, in cui si pronosticavano non solo la fine del
petrolio entro pochi decenni (sbagliandosi), ma anche (senza sbagliarsi) i
rischi connessi al consumo spregiudicato delle materie prime, al crescente
inquinamento, al divario Nord-Sud, ecc.
In realtà, da molto
tempo gli scienziati lanciano l’allarme sui rischi di un eccessivo e
sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sul
riscaldamento del pianeta, ecc. Ricordo di essere stato profondamente
impressionato da una conferenza promossa dal Club di Roma a Berna agli inizi degli
anni Settanta del secolo scorso, in cui si pronosticavano non solo la fine del
petrolio entro pochi decenni (sbagliandosi), ma anche (senza sbagliarsi) i
rischi connessi al consumo spregiudicato delle materie prime, al crescente
inquinamento, al divario Nord-Sud, ecc.  Già il Club di Roma parlava di «moderare gli
stili di vita», ma sono tante le azioni ordinarie in cui è possibile evitare
gli sprechi (non solo alimentari), ridurre i consumi (per esempio di acqua,
luce, gas, plastica), utilizzare i mezzi pubblici invece di quelli privati, differenziare
i rifiuti, investire maggiormente nella formazione continua, evitare comportamenti
nocivi alla salute, ecc.).
Già il Club di Roma parlava di «moderare gli
stili di vita», ma sono tante le azioni ordinarie in cui è possibile evitare
gli sprechi (non solo alimentari), ridurre i consumi (per esempio di acqua,
luce, gas, plastica), utilizzare i mezzi pubblici invece di quelli privati, differenziare
i rifiuti, investire maggiormente nella formazione continua, evitare comportamenti
nocivi alla salute, ecc.).