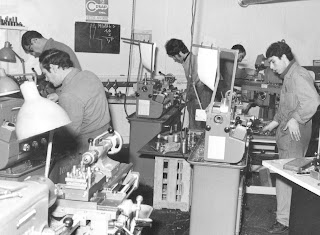Uno dei freni all’integrazione della seconda generazione degli immigrati italiani in Svizzera nella seconda metà del secolo scorso è stato il generale convincimento che l’emigrazione fosse una condizione temporanea, spesso penosa, per poter vivere meglio in seguito. Quasi tutti gli emigranti lasciavano l’Italia con l’intenzione di tornarvi prima o poi per proseguire la vita più serenamente. La temporaneità era voluta non solo dai migranti, ma anche dalle leggi e dagli ordinamenti svizzeri concepiti per impedire o rendere quasi impossibile la stabilizzazione degli immigrati: chiunque veniva in Svizzera per motivi di lavoro riceveva un permesso di soggiorno temporaneo, stagionale o annuale, rinnovabile solo se i bisogni dell’economia lo consentivano. La Svizzera non voleva essere un Paese d’immigrazione e pertanto l’integrazione non era favorita.
Immigrazione temporanea agli inizi del Novecento
 |
| Il passaggio del testimone tra la prima e la seconda generazione spesso si è inceppato! |
In quel periodo si svilupparono in Svizzera diverse comunità italiane, perché le grandi opere duravano generalmente molti anni. Ve n’erano in tutte le regioni della Svizzera (Basilea, Bienne, Chiasso, Ginevra, Kandesteg, Losanna, Lucerna, Zurigo e altre località) e godevano di una certa autonomia organizzativa con propri negozi, ristoranti e persino scuole per bambini e per adulti. Oltre all’italianità, uno dei principali collanti delle varie collettività era costituito dall’associazionismo solidaristico (società di mutuo soccorso) e socio-religioso (società culturali, musicali, Missioni cattoliche italiane, ecc.).
Agli inizi del Novecento, nelle grandi aree urbane esistevano già diversi gruppi organizzati, perché oltre agli immigrati temporanei c’erano già anche molti italiani «domiciliati» stabilmente in Svizzera, per lo più sposati (talvolta con donne svizzere) e impiegati a tempo indeterminato nell’industria. Erano dunque facili gli incontri, gli scambi, le feste comuni, anche se spesso tra i vari gruppi non c’era grande intesa perché, a parte l’appartenenza nazionale all’Italia, avevano ben poco in comune.
Le concentrazioni nelle «colonie»
In questa condizione di temporaneità-provvisorietà, agli immigrati italiani non veniva generalmente nemmeno in mente di dover imparare la lingua locale o di doversi integrare, come si direbbe oggi, per convivere meglio con gli svizzeri. D’altra parte, questo tipo di integrazione non interessava nemmeno a loro, che consideravano gli immigrati «lavoratori ospiti» (Gastarbeiter) e «stranieri» (non solo per la diversa nazionalità, ma anche perché ritenuti «estranei», diversi dal loro mondo).
La combinazione di questi atteggiamenti ed esigenze pratiche di sopravvivenza avevano portato nelle agglomerazioni urbane alla concentrazione degli immigrati italiani in grandi baraccopoli e in determinati quartieri operai (soprattutto nella Svizzera tedesca). Per identificarli si usavano frequentemente termini come «colonia italiana» (Italienerkolonie), «quartiere italiano» (Italienerviertel) ed espressioni equivalenti, con una connotazione prevalentemente giuridico-civile e geografica, ma talvolta anche socio-culturale per sottolinearne in particolare l’isolamento.
Mentre negli ultimi decenni i «quartieri italiani» sono scomparsi in tutte le grandi città, il termine «colonia» è rimasto ed è ancora ricordato non solo dalle associazioni «Colonie libere», ma anche dalla stampa. Quando vengono pubblicati i dati sugli stranieri a fine agosto o a fine anno, dai commenti giornalistici risulta spesso che gli italiani sono sempre «la colonia più numerosa». Dal termine «colonia» sono però scomparse quasi completamente sia la connotazione geografica che quella dell’isolamento e resta solo quella giuridico-civile per indicare semplicemente i «cittadini italiani».
I rapporti con la madrepatria
Nella seconda metà del Novecento e specialmente nel periodo che si sta trattando (1970-1990), il termine «colonia» non esprimeva tuttavia solo l’appartenenza degli immigrati italiani a una delle varie nazionalità straniere presenti nella Confederazione, ma indicava anche il loro legame con l’Italia del tipo colonia-madrepatria basato su interessi reciproci.
In epoca monarchica l’Italia considerava già gli emigrati cittadini italiani a tutti gli effetti, anche se fuori dell’Italia, tanto è vero che i maschi soggiacevano all’obbligo del servizio militare, le donne che sposavano un cittadino straniero perdevano automaticamente la cittadinanza italiana, i lavoratori erano in qualche modo tutelati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari (grazie ad accordi internazionali come il trattato tra l’Italia e la Svizzera del 1868). Da parte loro anche gli immigrati si consideravano in certo qual senso una «colonia italiana», benché spesso trascurata dalla madrepatria.
 |
| La FCLIS è una delle poche associazioni «storiche» che ancora sopravvive |
Caduto il fascismo, la lotta politica del dopoguerra tra la Democrazia Cristiana (DC) e il Partito comunista italiano (PCI) si è riverberata anche in Svizzera tra le associazioni italiane, producendo tuttavia un esito diverso: mentre in Italia aveva preso quasi subito il sopravvento la DC, in Svizzera cominciò a delinearsi la supremazia del PCI e più in generale della sinistra. A molti appariva chiaro che entrambi i fronti cercavano soprattutto consensi in occasione delle elezioni politiche. Soprattutto la seconda generazione si considerava totalmente estranea al gioco politico.
Poiché la lotta, anche se spesso solo sotterranea, non faceva bene all’immigrazione, nel 1970 si tentò un’intesa operativa almeno tra le principali organizzazioni (politiche). Da allora furono avanzate molte richieste e proposte che influirono probabilmente sul riconoscimento del diritto di voto all’estero e di una rappresentanza degli emigrati nel Parlamento italiano, sull’organizzazione di enti di rappresentanza da affiancare ai Consoli, sulla riorganizzazione delle scuole all’estero e forse su altro ancora, ma tutto era rivolto al rafforzamento dei rapporti della «colonia italiana» con la madrepatria.
Giovani trascurati
Oggi si assiste, in Svizzera, ad una irreversibile crisi dell’associazionismo tradizionale per il venir meno delle ragioni che avevano spinto alla creazione di tante associazioni negli anni Sessanta e Settanta e per l’incapacità delle stesse di osservare le tendenze che cominciavano a delinearsi già allora riguardanti la seconda generazione.
Soprattutto negli anni Ottanta e Novanta molte associazioni assistevano quasi impassibili all’invecchiamento dei loro membri e facevano ben poco per rinnovarsi. Nelle assemblee sociali si parlava preferibilmente di quote, di cariche, di pensioni, di rientri, raramente di problematiche giovanili. I figli degli immigrati, in generale, disertavano quegli incontri, non ambivano ad alcuna carica nelle associazioni e tantomeno a cariche politiche nelle varie istituzioni di rappresentanza, non pensavano nemmeno a tornare in Italia.
I giovani della seconda generazione volevano integrarsi nel Paese in cui erano nati e cresciuti, di cui faticavano ad apprendere la lingua e la cultura, in cui stavano costruendo i primi rapporti sociali e in cui si preparavano a vivere la loro vita professionale. La mentalità dominante nella «colonia italiana» spesso non li ha capiti, non li ha sostenuti, non ha favorito la loro integrazione e, perché no?, la loro naturalizzazione (anche quando reclamava vagamente i diritti politici per gli stranieri).
La concezione dell’emigrazione come momento temporaneo degli «italiani» all'estero impediva anche solo di concepire che quei giovani avrebbero potuto diventare ottimi portatori di «italianità» anche restando per sempre in Svizzera, anche diventando svizzeri. Per questo il percorso della loro integrazione riuscita è stato lungo e difficile.
Ora, però, che questi giovani hanno raggiunto ampiamente i loro obiettivi, sarebbe auspicabile che mostrino ai concittadini e alla società che è possibile e arricchente una buona integrazione linguistica, culturale, etica, in un mondo che sarà sempre più aperto, multiculturale e integrato.
Giovanni Longu
Berna, 25.11.2020